Spagnoli e indios: Gonzalo Guerrero e Jeronimo de Aguilar
Othersiders - Esperienze passate nell’incontro/scontro tra culture
«Cortés convocò me e Martin Camos di Biscaglia al suo cospetto, e ci chiese quale fosse la nostra opinione sulle parole Castilan, Castilan, che gli Indiani di Campeche avevano ripetuto così spesso, e facendo cenno ad est, quando sbarcammo lì, sotto il comando di Hernandez de Cordoba». Così Bernal Díaz del Castillo dà inizio al capitolo XXVII della sua Historia Verdadera de la Conquista de la Nuova España. Di quella e di altre conquiste Díaz era stato attore e testimone: mezzo secolo dopo la campagna del 1519-1521, quando Hernán Cortés aveva rovesciato l’Impero Azteco, Díaz volle scrivere dei semplici conquistadores che fecero l’impresa. Nel racconto di Francisco López de Gómara i suoi compagni erano svaniti nell’ombra di Cortés ed erano crudeli come demoni in quello di Bartolomé de Las Casas. Díaz rispose a entrambi restituendo carne e sangue a ciascuno di quegli uomini e affermando che «Noi andammo là per servire Dio e anche per arricchirci».
 Ma Díaz non esita a rammentare alcuni uomini che sembrano meritare più di altri il suo inchiostro. «[Cortés] disse che aveva spesso riflettuto sulla questione e che non poteva fare a meno di pensare che gli indigeni avevano alcuni Spagnoli tra di loro». Appena arrivato nel Nuovo Mondo, Cortés non pianta bandiere o asperge d’acqua santa le masse sconosciute, ma comincia a raccogliere informazioni. Tre giorni sull’isoletta di Cozumel, tappa obbligata per Veracruz ad est dello Yucatán, e capisce che gli indigeni avevano una strana familiarità con i castigliani. Parlando con i signori maya – i cacicchi – grazie all’aiuto del suo zoppicante interprete Melchorejo, Cortés viene a sapere che due spagnoli erano schiavi presso gli indigeni, a due giorni di cammino nell’entroterra. Sapendo che interpreti migliori potevano facilitare la sua impresa, fornisce un riscatto (le solite perline di vetro) e invia loro una lettera perché possano unirsi a lui. «Dopo un paio di giorni [gli indigeni] portarono la lettera ad uno dei due Spagnoli, il quale, come sapemmo poi, si chiamava Jeronimo de Aguilar […]. Letta la missiva e ricevuto il riscatto che avevamo mandato, egli ne gioì moltissimo e portò il riscatto al cacicco suo padrone per chiedere di essere liberato. Ottenuto questo andò in cerca del suo compagno, Gonzalo Guerrero, e lo mise al corrente di tutto». Presi gli stracci di San Francesco, l’andaluso Aguilar si era imbarcato giovanissimo per la Nuova Spagna; a Panama si era fatto coinvolgere in una lotta di fazioni e nel 1511, poco più che ventenne, era partito per Santo Domingo dove, documenti e denaro alla mano, avrebbe dovuto condurre una causa contro la fazione nemica. Ma finita la sua nave sugli scogli, Aguilar si era trovato sbattuto, con gli altri passeggeri, sulle coste orientali dello Yucatán. Alla fame e ai cannibali non erano sopravvissuti che lui e pochi altri: tra questi, quel Gonzalo Guerrero che ancora era fra i maya otto anni dopo. Acceso dalla gioia del ritorno al passato mai dimenticato, Aguilar non può che stupirsi della reazione del suo compagno. «Fratello Aguilar» gli dice Guerrero secondo Bernal Díaz «Qui ho sposato una delle donne di questo Paese, da cui ho avuto tre figli; conto quanto un cacicco e in guerra quanto un comandante. Va’ e che Dio sia con te: io non potrò più ritornare tra i miei compatrioti. La mia faccia è ormai trasfigurata secondo il costume indiano, e le mie orecchie sono state bucate; cosa direbbero i miei compagni se mi vedessero così vestito?». Aguilar invoca Cristo per convincere Guerrero a cambiar parere, ma invano; decide così di raggiungere Cortés da solo. «Quando Cortés vide quell’uomo così abbigliato, come ognuno di noi aveva fatto, chiese: dov’è lo Spagnolo? Quando Jeronimo lo sentì dir così indietreggiò secondo il costume indiano e disse: io sono qui». Stupefatti dalla pelle scurita e dai capelli rasati, lo rivestono da spagnolo e si fanno narrare la sua avventura.
Ma Díaz non esita a rammentare alcuni uomini che sembrano meritare più di altri il suo inchiostro. «[Cortés] disse che aveva spesso riflettuto sulla questione e che non poteva fare a meno di pensare che gli indigeni avevano alcuni Spagnoli tra di loro». Appena arrivato nel Nuovo Mondo, Cortés non pianta bandiere o asperge d’acqua santa le masse sconosciute, ma comincia a raccogliere informazioni. Tre giorni sull’isoletta di Cozumel, tappa obbligata per Veracruz ad est dello Yucatán, e capisce che gli indigeni avevano una strana familiarità con i castigliani. Parlando con i signori maya – i cacicchi – grazie all’aiuto del suo zoppicante interprete Melchorejo, Cortés viene a sapere che due spagnoli erano schiavi presso gli indigeni, a due giorni di cammino nell’entroterra. Sapendo che interpreti migliori potevano facilitare la sua impresa, fornisce un riscatto (le solite perline di vetro) e invia loro una lettera perché possano unirsi a lui. «Dopo un paio di giorni [gli indigeni] portarono la lettera ad uno dei due Spagnoli, il quale, come sapemmo poi, si chiamava Jeronimo de Aguilar […]. Letta la missiva e ricevuto il riscatto che avevamo mandato, egli ne gioì moltissimo e portò il riscatto al cacicco suo padrone per chiedere di essere liberato. Ottenuto questo andò in cerca del suo compagno, Gonzalo Guerrero, e lo mise al corrente di tutto». Presi gli stracci di San Francesco, l’andaluso Aguilar si era imbarcato giovanissimo per la Nuova Spagna; a Panama si era fatto coinvolgere in una lotta di fazioni e nel 1511, poco più che ventenne, era partito per Santo Domingo dove, documenti e denaro alla mano, avrebbe dovuto condurre una causa contro la fazione nemica. Ma finita la sua nave sugli scogli, Aguilar si era trovato sbattuto, con gli altri passeggeri, sulle coste orientali dello Yucatán. Alla fame e ai cannibali non erano sopravvissuti che lui e pochi altri: tra questi, quel Gonzalo Guerrero che ancora era fra i maya otto anni dopo. Acceso dalla gioia del ritorno al passato mai dimenticato, Aguilar non può che stupirsi della reazione del suo compagno. «Fratello Aguilar» gli dice Guerrero secondo Bernal Díaz «Qui ho sposato una delle donne di questo Paese, da cui ho avuto tre figli; conto quanto un cacicco e in guerra quanto un comandante. Va’ e che Dio sia con te: io non potrò più ritornare tra i miei compatrioti. La mia faccia è ormai trasfigurata secondo il costume indiano, e le mie orecchie sono state bucate; cosa direbbero i miei compagni se mi vedessero così vestito?». Aguilar invoca Cristo per convincere Guerrero a cambiar parere, ma invano; decide così di raggiungere Cortés da solo. «Quando Cortés vide quell’uomo così abbigliato, come ognuno di noi aveva fatto, chiese: dov’è lo Spagnolo? Quando Jeronimo lo sentì dir così indietreggiò secondo il costume indiano e disse: io sono qui». Stupefatti dalla pelle scurita e dai capelli rasati, lo rivestono da spagnolo e si fanno narrare la sua avventura.
Sfuggiti ai cannibali Cocomes che li avevano catturati, i naufraghi erano riparati presso Taxmar, signore maya della tribù Xiues Tutul, che li aveva fatti schiavi. Fatiche e percosse uccisero tutti tranne Aguilar e Guerrero. Il cacicco sapeva delle doti militari degli spagnoli e, dovendo porre fine alle lunghe ostilità con i Cocomes, aveva voluto farli suoi consiglieri di guerra; la carriera militare di Guerrero, d’una decina d’anni più vecchio del compagno, risaliva fino alle ultime gloriose battute della Reconquista. Insegnò ai maya di Taxmar a disporsi in formazione, a dilazionare gli attacchi, a diversificare le tattiche di offesa e difesa. Li schierò a falange e riuscì a battere definitivamente i Cocomes. Inebriato da fama e onore, Guerrero cominciò a vedere sotto una luce diversa i suoi nuovi padroni, mentre Aguilar continuava a tenere nascosto un libro di preghiere nelle pieghe del suo mantello. Per questo Aguilar sarebbe tornato dai suoi compatrioti, e Guerrero rimasto dai suoi. Dalla Crónica della Nueva España di Francisco Cervantes de Salazar sappiamo che in seguito Taxmar aveva ceduto Guerrero al cacicco di Chectemál, Nachan Can; questo lo affidò al capo dei suoi guerrieri, il nacom Balam. Un giorno, nell’attraversare un fiume, Balam fu attaccato da un caimano e Guerrero, anziché approfittarsene per fuggire, uccise la bestia salvando il suo padrone. Balam lo ricompensò con la libertà, ma Guerrero decise di non partire. Sposò la figlia del cacicco, Zazil Há (o Za’ asil) e s’integrò alla cultura maya, assumendone i costumi. Diego de Landa, vescovo dello Yucatán, rabbrividisce al pensiero che Guerrero potesse aver addirittura abbandonato Cristo in favore degli idoli dei suoi nuovi fratelli. (Relación de la cosas de Yucatán, III). «[Nachan Can] gli affidò le cose della guerra, nelle quali Guerrero era espertissimo. Egli riportò numerose vittorie sui nemici del suo signore e insegnò agli indiani a combattere, a costruire forti e bastioni…». Per questo, quando Cortés seppe da Aguilar che Guerrero non sarebbe mai tornato indietro, non poté che «ribadire che sperava ardentemente di ridurre quell’uomo in suo potere, perché non era un bene per noi che egli fosse tra gli Indiani».
Cortés sapeva il fatto suo e aveva visto giusto anche per l’avvenire. Quando le spedizioni di Hernandez de Cordoba (1517) e di Grijalva (1518) avevano per prime lambito le coste dello Yucatán, Guerrero aveva fin da allora esortato gli Indiani a non fidarsi degli Spagnoli. Una volta crollato l’Impero Azteco, lo Yucatán fu preso d’assalto dalla famiglia Montejo, ma Guerrero era pronto a difenderlo. Accusato da Aguilar di essersi lasciato corrompere dai costumi indigeni e di aver mescolato il suo sangue, Guerrero entrava nell’immaginario collettivo dei conquistadores e dei cronisti come un traditore della patria e della fede: chiunque mettesse piede in Yucatán s’imbatteva inevitabilmente in una figura, quella del rinnegato, sempre fonte d’inquietudine. Francisco de Montejo sarebbe passato alla storia come il conquistatore dello Yucatan, ma quando ne tentò l’occupazione, nel 1527, vide che non sarebbe stata facile impresa. L’idea che gli Spagnoli fossero dèi non aveva mai convinto i maya, che tra i precolombiani avevano sviluppato il grado più complesso di strutture mentali. Subito videro i bianchi per ciò che erano, ossia conquistatori; Guerrero insegnò loro a non temere i cavalli e i cannoni e che anche gli Spagnoli potevano morire. I maya di Chectemál sapevano che gli Spagnoli volevano mettere le mani sul loro strano comandante barbuto; così, nel 1531, quando alcuni di loro caddero prigionieri di Alonso de Ávila, ufficiale di Montejo che aveva compiuto un’incursione a Chectemál, gli diedero a bere che Guerrero fosse morto per cause naturali. Ma la realtà era ben diversa; i maya resistettero a oltranza e nel 1535 la conquista della penisola si era fatta tanto difficile che gli Spagnoli dovettero ritirarsi verso Veracruz e l’Honduras. È qui che si conclude la storia terrena di Gonzalo Guerrero. In una lettera del 14 agosto 1536, spedita a Carlo d’Asburgo dal governatore di Honduras Andrés de Cerezeda, troviamo scritto di una battaglia tra il conquistador Pedro de Alvarado e un cacicco locale di nome Ciçumba. Dopo lo scontro era stato ritrovato il cadavere nudo e tatuato di uno Spagnolo: si trattava di quel cristiano che stava tra i maya da più di vent’anni e che aveva combattuto Montejo nello Yucatán. Era venuto da Chectemál con cinquanta canoe per fermare gli Spagnoli, ma un colpo di archibugio l’aveva ucciso. Dieci anni dopo lo Yucatán era Spagna, ma i maya sarebbero sopravvissuti in carne ed ossa fino alla fine del XVII secolo, seminando di reminescenze indie le mescolanze culturali mesoamericane; in Honduras, in Messico, in Belize, in Guatemala il loro sangue scorre nelle vene dei meticci di cui Gonzalo Guerrero è giustamente considerato il padre. Quintana Roo, lo stato messicano dove giacciono le spoglie della signoria di Chectemál, così lo ricorda nel suo inno:
Esta tierra que mira al oriente Questa terra che guarda ad oriente
cuna fue del primer mestizaje Culla fu del primo meticciato
que nació del amor sin ultraje Che nacque dell’amore senza oltraggio
de Gonzalo Guerrero y Za'asil Di Gonzalo Guerrero e Za’asil
Parte della serie Othersiders
Galleria

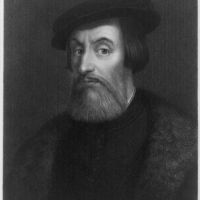
Commenta