Samuel Beckett, il maestro del fallimento
Dentro il racconto | Alla scoperta della prosa breve di uno degli autori più importanti del Novecento
Cinquant’anni fa, nell’estate del 1966, Samuel Beckett scrisse un racconto chiamato Bing. Inizia così:
“Tutto noto tutto bianco corpo nudo bianco un metro gambe aderenti come cucite. Luce calore suolo bianco un metro quadrato mai visto. Muri bianchi un metro per due soffitto bianco un metro quadrato mai visto. Corpo nudo bianco fisso solo gli occhi appena. Tracce intrico grigio pallido quasi bianco su bianco. Mani pendenti aperte palmo avanti piedi bianchi talloni uniti angolo retto. Luce calore facce bianche radianti. Corpo nudo bianco fisso hop fisso altrove”.
La prima volta volta che l’ho letto, mi ha ricordato il ritmo quasi cantato del meteo radiofonico per le isole britanniche della BBC: un flusso ipnotico di parole il cui significato all’inizio è completamente oscuro. Ma se insisti lo schema si fa evidente: “moderato o buono, occasionalmente scarso in seguito”/ “muri bianchi”, “un metro quadrato”, “cicatrici bianche”. In entrambi i casi, ci rendiamo presto conto di essere all’interno di un sistema di parole che realizzano compiti ben precisi, anche se si tratta di compiti che possono essere compresi solo dagli iniziati. Comprendere il meteo delle isole è un gioco da ragazzi in confronto. Entrare invece nel sistema di parole con cui Beckett lavorava a metà degli anni Sessanta è più complesso, non per ultimo perché il sistema era corrotto, un fallimento, come tutti i sistemi pensati da Beckett nel corso della sua lunga carriera.
Beckett aveva già avuto molti fallimenti artistici quando ne fece una vera e propria poetica
Beckett arrivò a credere che il fallimento fosse una parte essenziale del lavoro di un artista, così come lo era la ricerca del successo. Le espressioni che meglio incarnano questa filosofia sono apparse nel romanzo del L’innominabile: “Devi andare avanti. Non riesco ad andare avanti, Andrò avanti” e nella novella del 1983 Worstward Ho: “Mai provato. Mai fallito. Non importa. Prova di nuovo. Fallisci di nuovo, fallisci meglio”. Beckett aveva già avuto molti fallimenti artistici quando ne fece una vera e propria poetica. Nessuno voleva pubblicare il suo primo romanzo Sogno di donne attraenti o mediamente attraenti, e la raccolta di racconti Più pene che pane fu un disastro. La raccolta, che segue una serie di disavventure sessuali dell’alter ego di Beckett Belacqua Shuah in giro per Dublino, ha i suoi momenti di brillantezza, ma è una lettura impegnativa e frustrante. Piena di allusioni, sintassi ingannevole e vocabolario oscuro, la sua prosa deve essere potata come un cespuglio di spine. Come commenta il narratore del discorso nuziale di un personaggio, è “troppo denso per ottenere il suffragio universale”.
 Per tutto questo periodo, Beckett fu influenzato enormemente da James Joyce, al cui circolo si unì alla fine degli anni Venti. Nel proporre un racconto al suo editore londinese, Beckett notò senza problemi che la propria opera “puzzava di Joyce” e aveva ragione. Basta confrontare il suo brano, “e per la santa mosca non vi consiglio di chiedermi sotto quale genere di albero si trovavano quando lui le mise la mano addosso e se la godette. Il piacere della coscia attraverso le dita. Che cosa vuole per la bellezza della coscia?” con questo, dall’Ulisse: “Si lasciò andare a un improvviso rimbalzo della giarrettiera elastica che si stringeva contro la coscia calda della sua donna”. A cavallo tra i suoi venti e trent’anni, Beckett era privo di alcuna ambizione (cosa che, grazie all’assegno ricevuto dopo la morte del padre, poteva quasi permettersi di fare). Vagò per gran parte degli anni Trenta, dopo aver abbandonato una cattedra al Trinity College di Dublino. Tornò a Parigi, poi si trasferì a Londra, dove scrisse il romanzo Murphy e si sottopose alla psicoanalisi kleiniana. Girò la Germania e nel 1937 si stabilì a Parigi, dove visse fino alla morte, avvenuta nel 1989. Durante la Seconda guerra mondiale si unì alla Resistenza, fuggì da Parigi per evitare l’arresto e visse penosamente a Rossiglione. Questi anni di vagabondaggio, di guerra e di mancanza hanno influenzato il carattere della sua opera successiva. Nel 1945, lavorando in un ospedale della Croce Rossa a Saint-Lô, scrisse un saggio sulle rovine della città, “bombardata in una notte”, e descrisse “questo universo diventato provvisorio”. Nuove versioni del paesaggio disseminato di rovine e dell’ambiente post-apocalittico caratterizzeranno le ambientazioni e le atmosfere di molti dei suoi futuri lavori.
Per tutto questo periodo, Beckett fu influenzato enormemente da James Joyce, al cui circolo si unì alla fine degli anni Venti. Nel proporre un racconto al suo editore londinese, Beckett notò senza problemi che la propria opera “puzzava di Joyce” e aveva ragione. Basta confrontare il suo brano, “e per la santa mosca non vi consiglio di chiedermi sotto quale genere di albero si trovavano quando lui le mise la mano addosso e se la godette. Il piacere della coscia attraverso le dita. Che cosa vuole per la bellezza della coscia?” con questo, dall’Ulisse: “Si lasciò andare a un improvviso rimbalzo della giarrettiera elastica che si stringeva contro la coscia calda della sua donna”. A cavallo tra i suoi venti e trent’anni, Beckett era privo di alcuna ambizione (cosa che, grazie all’assegno ricevuto dopo la morte del padre, poteva quasi permettersi di fare). Vagò per gran parte degli anni Trenta, dopo aver abbandonato una cattedra al Trinity College di Dublino. Tornò a Parigi, poi si trasferì a Londra, dove scrisse il romanzo Murphy e si sottopose alla psicoanalisi kleiniana. Girò la Germania e nel 1937 si stabilì a Parigi, dove visse fino alla morte, avvenuta nel 1989. Durante la Seconda guerra mondiale si unì alla Resistenza, fuggì da Parigi per evitare l’arresto e visse penosamente a Rossiglione. Questi anni di vagabondaggio, di guerra e di mancanza hanno influenzato il carattere della sua opera successiva. Nel 1945, lavorando in un ospedale della Croce Rossa a Saint-Lô, scrisse un saggio sulle rovine della città, “bombardata in una notte”, e descrisse “questo universo diventato provvisorio”. Nuove versioni del paesaggio disseminato di rovine e dell’ambiente post-apocalittico caratterizzeranno le ambientazioni e le atmosfere di molti dei suoi futuri lavori.
Beckett arrivò a credere che il fallimento fosse una parte essenziale del lavoro di un artista
Sebbene Beckett avesse scritto alcune poesie in francese prima della guerra, fu nel dopoguerra che decise di dedicarsi completamente a questa lingua, “perché in francese è più facile scrivere senza stile”. Questa decisione, e il suo passaggio alla prima persona, si tradusse in una delle più sorprendenti trasformazioni artistiche della letteratura del XX secolo, in quanto la sua maniera coagulata, estenuante e autocosciente degli esordi lasciò il posto agli strani viaggi, e alle menti torturate e infestate, descritti nelle quattro novelle che produsse nel corso di pochi mesi nel 1946. Lo sfrattato, Il calmante e La fine, e in misura minore Primo amore (che Beckett, sempre il suo giudice più severo, considerò inferiore e soppresse per molti anni), descrivono la discesa dei loro narratori senza nome (forse lo stesso uomo) dalla rispettabilità borghese all’essere senza una casa e alla morte. Assistiamo a una successione di sfratti: dalla casa di famiglia, da qualche istituto, da tuguri e stalle, da cantine e panchine. C’è il sospetto che l’espulsione iniziale in ogni storia sia una forma di nascita, spesso caratterizzata in termini violenti. (Nel romanzo Watt, la nascita di un personaggio è descritta come la sua “espulsione”; in Aspettando Godot, Pozzo dice che la nascita avviene “a cavallo di una tomba”). Questi viaggi diventano surrogati del viaggio che compiamo nella vita, così come la percepisce Beckett: disorientata, disordinata e provvisoria, con solo brevi pause da un conflitto generale. Nella scena finale de La fine il narratore è incatenato a una barca che perde, con la vita che sembra prosciugarsi. È la monumentale cupezza di opere come queste (spesso attraversate da sprazzi di umorismo tagliente) che Harold Pinter, in una lettera del 1954, definiva Beckett “lo scrittore più coraggioso e spietato che esista, e più mi fa intingere il naso nella merda più gli sono grato”.
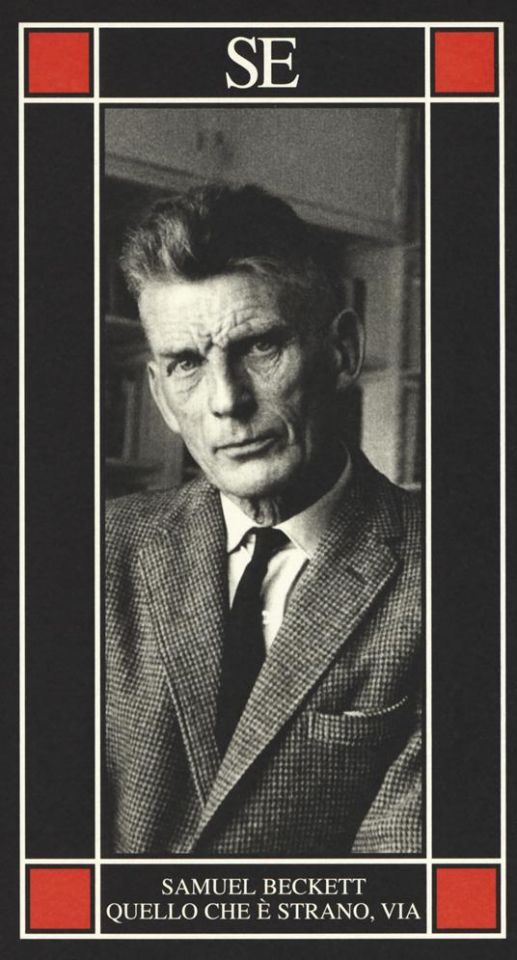 Dopo le quattro novelle, Beckett raggiunse un’impasse nella sua scrittura con Testi per nulla (1955). Il linguaggio è sull’orlo della rottura in questi brevi pezzi numerati. Il disprezzo in cui sono tenute le parole può essere riassunto con la frase “la testa e il suo ano la bocca”, contenuta nel racconto n.10. Nel n.11 si raggiunge un punto di crisi: “No, niente è nominabile, raccontare, no, niente può essere raccontato, che cosa allora, non lo so, non avrei dovuto cominciare”. Qui la giocosità presente nei Tre dialoghi e il coraggio tormentato del “Vado avanti” dell’Innominabile si trasformano in disperazione. Parlando della sua scrittura nei primi anni Sessanta, Beckett descrisse un processo di “discesa sotto la superficie” verso “l’autentica debolezza dell’essere”. Il fallimento rimaneva inevitabile perché “qualsiasi cosa viene detta è così lontana dall’esperienza” che “se si arriva davvero allo sfacelo, la minima eloquenza diventa insopportabile”. Così, il restringimento delle possibilità che i Testi per nulla descrivono sfocia nella claustrofobia delle opere “a spazio chiuso” degli anni Sessanta. A partire dal romanzo Come è (1961), raccontato da un uomo senza nome che giace nell’oscurità e nel fango, e proseguendo con Quello che è strano, via (1964), Immaginazione morta immaginate (1965) e il già citato Bing, Beckett descrive una serie di spazi geometricamente distinti (cubi, rotonde, cilindri) dove giacciono, o sono appesi, corpi bianchi, singolarmente o in coppia. Beckett aveva riletto Dante e qualcosa del suo Inferno e Purgatorio caratterizza questi spazi claustrofobici. Il linguaggio con cui vengono descritti è così frammentato che è difficile orientarsi: siamo in un sistema di parole in cui da ogni frase si diramano molteplici percorsi di significato, non a livello di interpretazione ma di comprensione elementare. Prendiamo ad esempio l’incipit di Immaginazione morta immaginate: “Da ogni parte non una traccia di vita, voi dite, bah, non c’è difficoltà, immaginazione mai morta, sì, morta bene, l’immaginazione morta immaginate”. Il “voi dite” guarda indietro a “da ogni parte non una traccia di vita”, o anticipa “bah, nessuna difficoltà”? Come scrive Adrian Hunter:
Dopo le quattro novelle, Beckett raggiunse un’impasse nella sua scrittura con Testi per nulla (1955). Il linguaggio è sull’orlo della rottura in questi brevi pezzi numerati. Il disprezzo in cui sono tenute le parole può essere riassunto con la frase “la testa e il suo ano la bocca”, contenuta nel racconto n.10. Nel n.11 si raggiunge un punto di crisi: “No, niente è nominabile, raccontare, no, niente può essere raccontato, che cosa allora, non lo so, non avrei dovuto cominciare”. Qui la giocosità presente nei Tre dialoghi e il coraggio tormentato del “Vado avanti” dell’Innominabile si trasformano in disperazione. Parlando della sua scrittura nei primi anni Sessanta, Beckett descrisse un processo di “discesa sotto la superficie” verso “l’autentica debolezza dell’essere”. Il fallimento rimaneva inevitabile perché “qualsiasi cosa viene detta è così lontana dall’esperienza” che “se si arriva davvero allo sfacelo, la minima eloquenza diventa insopportabile”. Così, il restringimento delle possibilità che i Testi per nulla descrivono sfocia nella claustrofobia delle opere “a spazio chiuso” degli anni Sessanta. A partire dal romanzo Come è (1961), raccontato da un uomo senza nome che giace nell’oscurità e nel fango, e proseguendo con Quello che è strano, via (1964), Immaginazione morta immaginate (1965) e il già citato Bing, Beckett descrive una serie di spazi geometricamente distinti (cubi, rotonde, cilindri) dove giacciono, o sono appesi, corpi bianchi, singolarmente o in coppia. Beckett aveva riletto Dante e qualcosa del suo Inferno e Purgatorio caratterizza questi spazi claustrofobici. Il linguaggio con cui vengono descritti è così frammentato che è difficile orientarsi: siamo in un sistema di parole in cui da ogni frase si diramano molteplici percorsi di significato, non a livello di interpretazione ma di comprensione elementare. Prendiamo ad esempio l’incipit di Immaginazione morta immaginate: “Da ogni parte non una traccia di vita, voi dite, bah, non c’è difficoltà, immaginazione mai morta, sì, morta bene, l’immaginazione morta immaginate”. Il “voi dite” guarda indietro a “da ogni parte non una traccia di vita”, o anticipa “bah, nessuna difficoltà”? Come scrive Adrian Hunter:
«La punteggiatura qui ha l’effetto non di aiutare l’interpretazione, ma di spezzare ulteriormente qualsiasi catena di significato nel linguaggio. Una semplice frase orientativa come “voi dite” si aggira incerta tra le sue virgole; invece di assicurare gli atti del discorso che la circondano, funziona come una sorta di porta girevole dalla quale si esce e si entra nei vari campi semantici del brano».
Nell’opera successiva, Basta (1965), Beckett abbandona sia la prima persona che la virgola (se ne trovano solo poche in tutta la sua prosa successiva), le sue frasi diventano terse come bollettini, brevi ripensamenti (“aggettivo dopo aggettivo”, in una descrizione) che consistono tipicamente in parole monosillabiche o bisillabiche, che cercano – fallendo – di chiarire qualsiasi immagine o sensazione stia cercando di esprimere. Hugh Kenner ha scritto in modo memorabile di questa fase, dicendo che Beckett:
“Sembra incapace di punteggiare una frase, figuriamoci di costruirne una. Sempre più profondamente penetra nel cuore della totale incompetenza, dove i pezzi più semplici, le più semplici frasi di tre parole, volano via nelle sue mani. È il non-maestro, l’antivirtuoso, l’habitué della non-forma e dell’anti-materia, l’Euclide della zona oscura dove tutti i segni sono negativi, il comico del disastro totale”.
La valutazione di Kenner riecheggia le parole dello stesso Beckett in un’intervista al New York Times del 1956, quando contrappose il suo approccio a quello di Joyce: “Lui tende all’onniscienza e all’onnipotenza come artista. Io lavoro con l’impotenza, l’ignoranza”. L’impasse raggiunta nei Testi per nulla continua in un racconto come Senza (1969), che di fatto esaurisce le parole: la seconda metà del testo si limita a duplicare la prima metà con le parole riordinate, lasciandoci, secondo la descrizione di JM Coetzee, con “una finzione di zero netto tra le mani, o piuttosto con le tracce cancellate di una coscienza che elabora e rigetta le proprie invenzioni”. Strategie come queste fanno sì che districarsi nell’opera di Beckett sia ancora più impegnativo per il lettore, al punto che alcuni critici hanno individuato nell’inutilità il suo stesso scopo. Nel caso di Bing, questa posizione è fortemente confutata in un saggio del 1968 di David Lodge. Pur riconoscendo che è “straordinariamente difficile leggere l’intera opera, per quanto breve, con una concentrazione prolungata”, e che le parole cominciano presto a “scivolare e a confondersi davanti agli occhi, e a risuonare in modo sconcertante nell’orecchio”, egli conclude che “quanto più da vicino conosciamo Bing, tanto più diventiamo certi che le parole usate hanno una certa importanza, e che si riferiscono a qualcosa di più specifico della futilità della vita o della futilità dell’arte”.
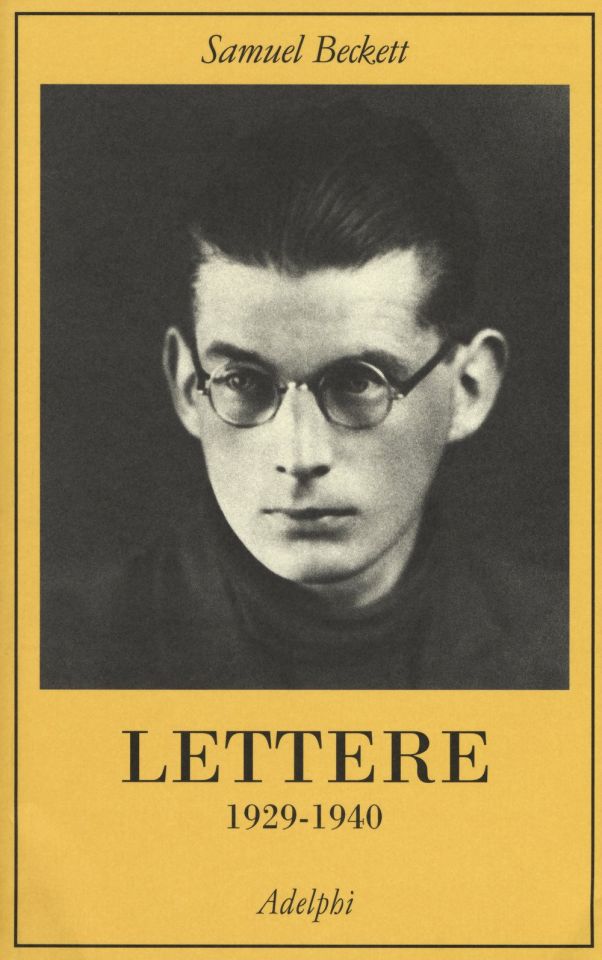 La fase dello spazio chiuso di Beckett culmina ne Lo spopolatore (1970), una visione da incubo di un cilindro sigillato all’interno del quale i “fuggitivi” circolano fino a quando la futilità o la morte li sopraffanno. Lo spopolatore segue Dante in quella che un recensore ha definito “l’arte di un mondo di camere a gas”. È scritto con una distanza antropologica, il cilindro è descritto in modo dettagliato e con una lunghezza spaventosa. Nonostante la chiarezza del suo linguaggio rispetto a Bing o a Senza, è la più proibitiva delle sue opere in prosa brevi. Passò quasi un decennio prima che emergesse una prosa breve più significativa, ma quando ciò avvenne un altro cambiamento era avvenuto. I terrificanti spazi chiusi erano crollati e scomparsi, sostituiti dalle praterie crepuscolari di Ultimi sussurri (1988), o dalla capanna isolata, dalla “zona di pietre” e dal cerchio di sentinelle misteriose di Mal visto mal detto (1981). Il linguaggio rimane problematico, ma è stato raggiunto un livello di accettazione. La frase “qual è la parola sbagliata?” ricorre in Mal visto mal detto, come a dire: “Naturalmente il linguaggio è insufficiente, ma l’approssimazione è meglio di niente”: “Granito di varietà non comune, certo. Nero come la giada il diaspro che ne screzia il candore. Sulla sua parola sbagliata, il suo volto inclinato è un oscuro graffito”. In questi racconti, scritti nell’ultimo decennio della sua vita e in cui ambientazioni stilizzate si fondono con materiale autobiografico, spesso tratto dalla sua infanzia, Beckett sembra consegnarci la fonte della sua creatività, al momento in cui un’idea scatta nella mente cosciente. Il terreno e le strutture di Mal visto mal detto sembrano nascere nel momento stesso in cui li leggiamo. “Attento”, scrive l’autore, portando timidamente la sua creazione nel mondo come se stesse custodendo la fiamma di un fiammifero: “Le due zone formano un insieme approssimativamente circolare. Come se fossero delineate da una mano tremante. Diametro. Attenzione. Diciamo un metro e mezzo”.
La fase dello spazio chiuso di Beckett culmina ne Lo spopolatore (1970), una visione da incubo di un cilindro sigillato all’interno del quale i “fuggitivi” circolano fino a quando la futilità o la morte li sopraffanno. Lo spopolatore segue Dante in quella che un recensore ha definito “l’arte di un mondo di camere a gas”. È scritto con una distanza antropologica, il cilindro è descritto in modo dettagliato e con una lunghezza spaventosa. Nonostante la chiarezza del suo linguaggio rispetto a Bing o a Senza, è la più proibitiva delle sue opere in prosa brevi. Passò quasi un decennio prima che emergesse una prosa breve più significativa, ma quando ciò avvenne un altro cambiamento era avvenuto. I terrificanti spazi chiusi erano crollati e scomparsi, sostituiti dalle praterie crepuscolari di Ultimi sussurri (1988), o dalla capanna isolata, dalla “zona di pietre” e dal cerchio di sentinelle misteriose di Mal visto mal detto (1981). Il linguaggio rimane problematico, ma è stato raggiunto un livello di accettazione. La frase “qual è la parola sbagliata?” ricorre in Mal visto mal detto, come a dire: “Naturalmente il linguaggio è insufficiente, ma l’approssimazione è meglio di niente”: “Granito di varietà non comune, certo. Nero come la giada il diaspro che ne screzia il candore. Sulla sua parola sbagliata, il suo volto inclinato è un oscuro graffito”. In questi racconti, scritti nell’ultimo decennio della sua vita e in cui ambientazioni stilizzate si fondono con materiale autobiografico, spesso tratto dalla sua infanzia, Beckett sembra consegnarci la fonte della sua creatività, al momento in cui un’idea scatta nella mente cosciente. Il terreno e le strutture di Mal visto mal detto sembrano nascere nel momento stesso in cui li leggiamo. “Attento”, scrive l’autore, portando timidamente la sua creazione nel mondo come se stesse custodendo la fiamma di un fiammifero: “Le due zone formano un insieme approssimativamente circolare. Come se fossero delineate da una mano tremante. Diametro. Attenzione. Diciamo un metro e mezzo”.
Beckett sembra consegnarci la fonte della sua creatività
È un’ironia della reputazione postuma di Beckett che le sue opere teatrali siano oggi molto più conosciute della sua prosa, sebbene egli considerasse quest’ultima il suo obiettivo principale. Che abbia scritto alcuni dei più grandi racconti del XX secolo mi sembra un’affermazione incontrovertibile, eppure il suo lavoro in questo genere è relativamente oscuro. In parte si tratta di un problema di classificazione. Come dice una nota bibliografica: “La distinzione tra un racconto discreto e un frammento di romanzo non è sempre chiara nell’opera di Beckett”. Gli editori hanno contribuito a questa confusione: come prova della fobia britannica per i racconti brevi, è difficile battere il soffietto editoriale di John Calder che definisce il racconto Immaginazione morta immaginate, di 1.500 parole, “forse il romanzo più breve mai pubblicato”. Ci sono poi esempi come l’esclusione di Beckett dall’Oxford Book of Irish Short Stories del 1989 da parte di William Trevor per l’insensata ragione che egli esprimeva le sue idee “con maggiore abilità in un altro mezzo”, o l’esclusione di Anne Enright dalla sua stessa selezione per Granta.
Sospetto che il vero problema della narrativa breve di Beckett sia la sua difficoltà, e che i suoi più grandi successi in questa forma non siano conformi a quelli che alcuni intellettuali suppongono essere i tratti distintivi del genere. Per quanto sfortunata possa essere la negligenza che ne deriva, questa è una posizione appropriata per uno scrittore che ha sempre lottato per sviluppare nuove forme. Se la storia del racconto breve fosse mappata, egli apparterrebbe a una regione lontana. Ma l’isolamento non avrebbe importanza. “Non trovo la solitudine angosciante, al contrario”, scrive in una lettera del 1959. “I buchi nella carta si aprono e mi portano a braccia aperte in qualsiasi luogo”.
Chris Power è un critico letterario e scrittore inglese, autore della raccolta di racconti Mothers (2018) e del romanzo A Lonely Man (2021). Dal 2007 tiene sul Guardian la rubrica monografica dal titolo A brief survey of the short story, di cui questo articolo pubblicato il 07/07/2016 fa parte ► Samuel Beckett, the maestro of failure | Traduzione di Sonia Valentini

Commenta