Raccontare una storia è costruire una casa
La vita dentro e fuori dalle storie nell’intervista a Eleonora Daniel, autrice di La polvere che respiri era una casa
Gennaio 2025. Los Angeles brucia e qui a Roma fa meno freddo di quanto dovrebbe, ma comunque abbastanza per farmi andare in giro con maglia termica, maglione, sciarpa, cappello, guanti imbottiti e giacca pesante. Mentre mi siedo nella cucina di Eleonora Daniel e dei suoi coinquilini (ancora con la giacca ma senza sciarpa cappello e guanti), guardo i fornelli, l’accendigas e le tende e non riesco a non pensare al fatto che Eleonora ha appena pubblicato un romanzo su una donna che dà fuoco alla propria casa. Il romanzo in questione si chiama La polvere che respiri era una casa, è uscito per Bollati Boringhieri ed è un esordio. È una storia che parla di relazioni, racconti e incomunicabilità, e in cui tutto ha a che fare con il fraintendimento, con l’omissione e con l’impossibilità di una spiegazione. È un romanzo metaletterario, che mette in scena processi creativi di natura varia, a volte artistici e altre puramente emotivi. Un romanzo che chiede di essere ascoltato per la sua voce almeno quanto per la sua storia (e il blurb di Giorgio Vasta in quarta di copertina è un segnale chiaro in questo senso), un romanzo sulle cose che «iniziano e finiscono come le storie: dal nulla».
È una storia che parla di relazioni, racconti e incomunicabilità, e in cui tutto ha a che fare con il fraintendimento
La polvere che respiri era una casa non è un testo facile da presentare. Nella prima metà, la voce narrante è «noi», una prima persona plurale che indica non tanto la somma di due persone quanto l’entità-coppia che personifica una relazione. Ci sono un lui e una lei senza nome, e il noi è tirato in ballo solo per le azioni che riguardano entrambi:
Sono passati quattro anni dal nostro arrivo qui. Alcune cose sono cambiate, molte altre no. Lei ha i capelli più corti, sembra più elegante, più adulta e ogni tanto più stanca. Lui ha pian piano invaso lo spazio sulla credenza in salotto, ingombrandola tutta di carte; ha smesso di fumare e poi ripreso e poi smesso di nuovo (ma ogni tanto, in compagnia, dopo un pasto abbondante, se beve troppo, se lei non c’è, una sigaretta la prende in mano); ha avuto una promozione e abbiamo festeggiato a lungo, abbiamo potuto accelerare il ritmo con cui estinguere il mutuo. Si sono rotti dei bicchieri, i calici sono diventati dispari e tornati pari; sono andati anche due piatti, piano e fondo ma di due servizi diversi, e una tazzina – la coppia di tazzine in ceramica che abbiamo riportato a casa dalla Grecia la trattiamo però con tutta la cura del mondo, quasi non le usiamo per assicurarci di non romperle (ma qual è il confine tra avere cura e isolare, mettere sotto teca, sott’olio, dimenticare?).
Il «noi», nella seconda metà, scompare (fatta eccezione per una frase) e i personaggi acquisiscono nomi, voci e percorsi ben distinti. La prima metà è la storia di una relazione, una casa e di come una relazione può essere una casa; la seconda metà racconta il modo in cui non avere più una casa può ispirare a scrivere una storia.
Partiamo dal titolo: il tuo romanzo La polvere che respiri era una casa prende il nome da una citazione dai Quattro quartetti di T.S. Eliot. Qual è la storia dietro questa scelta?
La prima volta che ho letto i Quattro quartetti, tempo fa, non posso dire di averli capiti del tutto. È stata una lettura di pancia, leggevo e rileggevo intuendo dei significati che forse c’erano e forse no ma che di rilettura in rilettura si intensificavano. Quella frase mi è piaciuta subito e ormai è uno dei miei versi preferiti in assoluto. L’opera intera ha molto a che fare con il tempo e la disgregazione, con gli inizi e le fini, con la circolarità di qualcosa che muore e rinasce. Sono temi centrali nel mio romanzo, ma forse sono più affezionata al verso che all’opera. Per il titolo ho scelto una traduzione di Raffaele La Capria, anche se poi ho trovato una vecchia edizione della stessa traduzione e lì il verso non recitava «che respiri» (in inglese è un participio passato: «dust inbreathed was a house»). L’ho scelto perché mi piace il verso e soprattutto mi piace nel suo contesto: «Polvere sospesa nell’aria / Segna il punto dove una storia è finita. / La polvere che respiri era una casa – / Il muro, il pannello e il topo». La polvere resta, è il rimasto di qualcosa, e mi piace pensare che possa «segnare» il punto in cui è finita una storia, mi piace il legame tra polvere casa e storia e il modo in cui si ricollega tutto.
Tanta della narrativa italiana contemporanea è dichiaratamente ispirata alla biografia degli autori stessi. Ora stiamo registrando questa intervista nella cucina di una casa in affitto, con coinquilini che entrano ed escono dalla stanza per lavare piatti o chiedere consiglio su come vestirsi: il tuo romanzo parte da una premessa realistica, ma mi viene da pensare che oggi, per un’autrice millennial che lavora nell’editoria – Eleonora è caporedattrice e editor di Accento Edizioni – parlare di trentenni che possono permettersi serenamente una casa, un mutuo e un certo stile di vita è comunque un racconto di fantasia.
Trovo in generale molto avvilente il principio secondo cui tu dovresti scrivere solo delle cose che conosci. Non c’è niente di male a farlo se vuoi farlo, ma è avvilente pensare che quella sia l’unica possibilità. Forse quello che ho fatto è rischioso, in un certo senso, perché è molto facile che sembri la mia vita. Se scrivessi di tutt’altro sarebbe diverso. Se il libro fosse solo Erba – un racconto scritto dalla protagonista femminile che compare integralmente nel romanzo – nessuno penserebbe che ho un passato da sovrana di un antico regno in cui ho fatto trapiantare ed estirpare piante a caso. Invece probabilmente a qualcuno verrà spontaneo pensare che ho avuto una relazione finita tragicamente, o che non posso avere figli, o che ho una casa, e sarebbero tre assunti sbagliati. E non sono neanche una piromane, ci tengo a precisarlo – lei ride, io allontano l’accendigas. Ho usato la fantasia e ho scelto uno scenario contemporaneo e plausibile. Ma questo lo vivo più come un rischio che come un merito.
_1898-1899._the_barnes_foundation,_philadelphia_.jpg)
Case a Kervilahouen, Belle Ile (1896) di Henri Matisse
Parlando invece degli elementi più fantastici, nelle tue pagine si sente un certo gusto per un linguaggio mitico, biblico. Da dove arriva la tua passione per i testi sacri?
Sono cresciuta da cristiana cattolica, come tante persone. In realtà, al di là del mio allontanamento a posteriori dalla religione, sono contenta di essere entrata in contatto con l’Antico Testamento e con le parti che preferisco del Nuovo Testamento, che non sono i vangeli. È un bagaglio di storie infinito e interessantissimo e, anche se non ne sono una grande esperta, quelle storie sono come le storie che mi raccontavano i miei genitori a letto. La Bibbia o i miti greci sono un bagaglio culturale immenso. Mi dispiace di non avere la stessa familiarità con altri testi sacri o di altre culture, certo, ma intanto sono contenta di quello che ho, e il resto lo recupererò.
E quali sono le storie che ti raccontavano i tuoi genitori?
Le storie che inventa il protagonista quando gioca con i biscotti vengono da mio padre. Spesso a tavola mentre stavamo mangiando tirava fuori questa storia di un dinosauro che andava ai banchetti e sbranava tutto; prima tutto il cibo e poi tutte le persone. Era la sua storia e ogni volta era un pochino diversa. In realtà la persona che nel ricordo lego di più alle storie era mia zia, che poi non è tecnicamente mia zia ma un’amica di famiglia. Lei d’estate durante le passeggiate raccontava delle storie meravigliose. Non erano storie inventate da lei. Erano fiabe di diverse culture che lei leggeva e poi ci raccontava. Ed era lei quella che più di tutti ce le raccontava. L’imprinting con le storie arriva da lei, penso.
Quindi il tuo rapporto con la narrativa è molto legato alla fiaba.
Sì, fiabe e Bibbia. E poi c’erano i cartoni animati della Disney che vedevo e raccontavo a mio fratello minore. Io magari a due, tre anni vedevo questi film e poi li riraccontavo molto male a mio fratello, riassumendoli. Altre volte, invece, inventavo storie per lui.
Hai iniziato a raccontare storie raccontandole a tuo fratello. Da molto giovane.
Sì, a quanto dice una mia amica pare che alle elementari io andassi in giro sostenendo che avrei scritto un romanzo su un tizio che stava per essere giustiziato su una sedia elettrica. Io non lo ricordo.
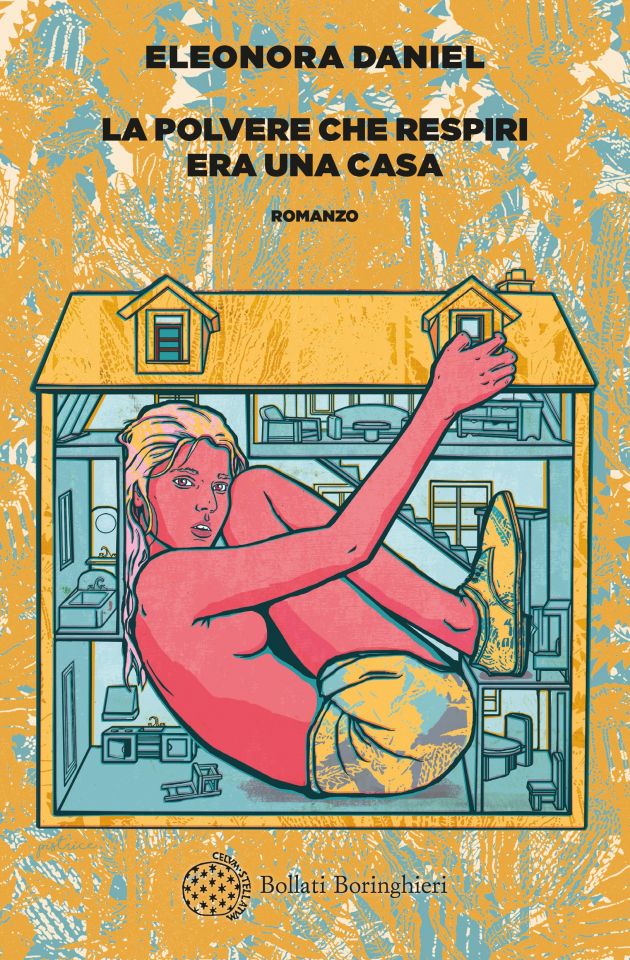 Leggendo il romanzo è difficile non fare un paragone con i racconti che hai già pubblicato (su Altri Animali e Calvario, negli Atomi di Oblique e nell’antologia Bridge of Stories). Nei tuoi racconti c’è qualcosa del McCarthy più biblico, ma anche un modo colto e bambinesco di giocare con le parole che potrebbe ricordare Michele Mari e qualcos’altro di fiabescamente violento; la durezza e la spietatezza di alcune frasi forse arriva da Ágota Kristóf, e poi c’è una letterarietà un po’ convenzionale ma molto curata. Nel romanzo ritrovo la stessa autrice di quei racconti, forse semplificata, più sbilanciata su quest’ultimo aspetto, ma comunque la stessa scrittrice. Quali riferimenti hai avuto per questo romanzo?
Leggendo il romanzo è difficile non fare un paragone con i racconti che hai già pubblicato (su Altri Animali e Calvario, negli Atomi di Oblique e nell’antologia Bridge of Stories). Nei tuoi racconti c’è qualcosa del McCarthy più biblico, ma anche un modo colto e bambinesco di giocare con le parole che potrebbe ricordare Michele Mari e qualcos’altro di fiabescamente violento; la durezza e la spietatezza di alcune frasi forse arriva da Ágota Kristóf, e poi c’è una letterarietà un po’ convenzionale ma molto curata. Nel romanzo ritrovo la stessa autrice di quei racconti, forse semplificata, più sbilanciata su quest’ultimo aspetto, ma comunque la stessa scrittrice. Quali riferimenti hai avuto per questo romanzo?
Più o meno sono quelli che hai detto. Manca la poesia di T.S. Eliot e Frost, che per me è stata importantissima. Quando parli del gusto per le frasi molto dure, sicuramente c’è Kristóf, soprattutto la Trilogia della città di K, ma tantissimo viene da Amelia Rosselli, secondo me. Un autore tra i miei preferiti per quanto riguarda le riscritture, ma in un senso più giocoso che mitico, è Savinio. E poi ancora un altro autore italiano novecentesco che mi piace molto, soprattutto per la sua eleganza – e non è detto che io l’abbia ereditata, dico solo che è un mio modello – è Giovanni Arpino. Ho proprio il ricordo della prima volta che ho letto elenchi di aggettivi o sostantivi senza virgole, una cosa che ha avuto un forte impatto su di me, ed era lui. E per finire l’unico riferimento che non so quanto abbia influenzato il libro ma sicuramente ha influenzato me è la Virginia Woolf de Le onde.
I riferimenti sono la poesia di T.S. Eliot e Frost, sicuramente c’è Kristóf, soprattutto la Trilogia della città di K, Amelia Rosselli e Giovanni Arpino
Tra le cose uscite in tempi più recenti, ho amato Il vangelo dei bugiardi di Naomi Alderman. Sì per lo stile, ma a conquistarmi è stato il fatto che, guardando al testo come una riscrittura, le parti che sembrano più distanti dalla narrazione canonica dei vangeli sono in realtà le più filologicamente accurate, per quello che sappiamo del Gesù storico.
 Eleonora somiglia al modo in cui scrive. Dà l’idea di essere precisa, ordinata e rigorosa, e lo è, ma poi emerge l’energia caotica e gioiosamente infantile con cui parla del Gesù storico e della violenza nei testi sacri, o di quando ha letto per la prima volta i suoi scrittori preferiti, e inizia a delinearsi un amore per la letteratura più intenso e vibrante di quanto la postura austera e l’accento milanese lascerebbero sperare.
Eleonora somiglia al modo in cui scrive. Dà l’idea di essere precisa, ordinata e rigorosa, e lo è, ma poi emerge l’energia caotica e gioiosamente infantile con cui parla del Gesù storico e della violenza nei testi sacri, o di quando ha letto per la prima volta i suoi scrittori preferiti, e inizia a delinearsi un amore per la letteratura più intenso e vibrante di quanto la postura austera e l’accento milanese lascerebbero sperare.
Nel romanzo, questo slancio arriva non solo attraverso la cura per la lingua, ma anche nella struttura della trama. I protagonisti, che nella seconda parte scopriamo chiamarsi Margherita e Riccardo, scrivono due racconti, uno a testa. Li scrivono per gioco, nessuno dei due è uno scrittore di professione, ma in entrambi i casi il processo creativo ha un ruolo cardine nella storia. Oltre a leggerli integralmente, assistiamo al modo in cui i protagonisti trovano l’ispirazione per i loro, ne ascoltiamo la voce e, forse, indoviniamo le emozioni dei due autori più di quanto loro stessi non siano consapevoli di comunicare mentre scrivono. In questo senso, La polvere che respiri era una casa è un romanzo che esplora e mette in scena, più che la letteratura stessa, il processo creativo che ne rende possibile l’esistenza.
La scrittrice Antonella Lattanzi ha detto che il libro parla di «come le storie, tutte le storie, nascono». Nel tuo romanzo compaiono due racconti, intitolati Erba e Acqua, scritti dai protagonisti. In entrambi i racconti alcuni elementi suggeriscono al lettore quali eventi e dettagli potrebbero aver ispirato i personaggi mentre scrivevano. Penso per esempio al modo in cui le operazioni di trapianto del glicine nella costruzione della casa influenzano Margherita, che le rielaborerà in Erba. Quanto è stato ricercato questo legame, e quanto è capitato spontaneamente?
È una via di mezzo, come sempre. All’inizio è capitata e poi piano piano è diventata più consapevole. Tornando indietro inserivo elementi nel testo per collegarlo meglio ai racconti. Non è successo tanto per Erba quanto per Acqua, perché Erba era un racconto preesistente, che avevo scritto ma a cui mancava qualcosa, e che poi ha avuto davvero vita quando l’ho riscritto pensandolo in un romanzo che ancora non esisteva. Per me da subito il legame più forte tra Erba e la protagonista è stato la volontà di potere e controllo, poter costruire e distruggere qualcosa ma soprattutto poterlo fare senza un criterio. Il re vuole il suo bosco matto, cresciuto dal nulla, e poi lo distrugge senza motivo. Quello che fa Margherita alla casa non è giustificato né spiegato, o meglio: una spinta c’è ed è che non ama più la persona con cui vive, ma quello che fa non ha una correlazione sensata con i fatti, non è spiegabile né tantomeno comunicabile.
Per Acqua il discorso è diverso. Doveva essere il racconto di un uomo che ha una passione per la scrittura e ha bisogno di superare un blocco. Nel romanzo non segui la stesura di Erba, sai che lei scrive ma non sai cosa sta scrivendo; mentre Acqua nasce da un’esigenza specifica, è più calato nella storia e per questo più seminato. Ci sono molti più elementi che il protagonista osserva o si appunta e che poi userà nel racconto. Sono piccoli dettagli, molto piccoli, ma sono dettagli a cui tenevo.
E poi pensa: Forse è questa la casa della nonna, forse questo glicine è quello di sempre e io non l’ho mai capito. E poi pensa ai rami nodosi come il sangue d’agnello sulle porte d’Egitto – ma quale flagello vuoi che portino le mie braccia vuote. E poi, solo alla fine, pensa ancora: È sempre lei. E quel pensiero, a cucchiaiate, gli scava il fondo dell’esofago e lo lascia vuoto.

Paesaggio corso (1898) di Henri Matisse, MOMA, New York
A proposito di scrittura: entrambi i protagonisti riescono a scrivere i loro racconti solo quando sanno davvero a chi si stanno rivolgendo. Lei sa subito che non avranno un figlio e scrive Erba al marito, allo spettro di qualcosa che non esisterà mai oppure a sé stessa. Lui invece non riesce a scrivere Acqua finché non scopre che non ci sarà mai un bambino ad ascoltare quella storia. E credo che abbia senso perché anche se viene detto spesso che scrivere è una cosa solitaria (e lo è), raccontare una storia rimane un atto comunicativo, per certi versi altruista, e forse non puoi raccontare qualcosa se non lo stai raccontando a qualcuno.
È interessante, non ci avevo mai fatto caso. Io l’avevo sempre vista da un’altra prospettiva. Quando ho scritto il romanzo pensavo al punto di vista dello scrivente, quindi ribaltato rispetto alla tua osservazione. Ne facevo un discorso di autorialità. Di autonomia, lucidità e scelta di chi scrive. Per me, Margherita scrive fin da subito non tanto perché sa a chi sta scrivendo. Magari lo sa, nella sua confusione, ma se scrive è prima di tutto perché ha qualcosa da dire e sa cosa vuole dire. Sa che quella è la storia che vuole raccontare: una storia di inspiegabilità, brutalità e scoppio. Lui non riesce a scrivere perché non riesce a capire che cosa vuole dire e come vuole dirlo, e finché non lo sa non può scrivere. Per quanto riguarda me, scrivere un libro è un buon modo di parlare da sola, forse perché sai che in fondo non stai davvero parlando a un muro. Ti inventi qualcosa che non sai come e quando arriverà a qualcuno ma sai che prima o poi arriverà, e non potrai controllarne la ricezione. Non potrai evitare fraintendimenti.
In esergo hai usato una frase dell’artista Louise Bourgeois, tratta dall’opera He Disappeared into Complete Silence, che recita: «Una volta un uomo stava raccontando una storia, era anche una buona storia, e la cosa lo rendeva molto felice, ma la raccontò così in fretta che nessuno la capì». Che legame c’è fra l’opera di Bourgeois e il tuo romanzo?
He Disappeared into Complete Silence è una serie di tavole accompagnate da microfinzioni, storie che iniziano e finiscono nel giro di una breve frase. Alcune di queste storie sono più tranquille, altre molto inquietanti. Le ho viste al Guggenheim di Bilbao e mi hanno colpita, soprattutto quella frase. Forse il motivo per cui il libro che ho scritto è così legato a quei temi non è solo il fatto che mi interessano, ma che la citazione stessa ha in parte ispirato il romanzo. L’ho sempre pensato a partire da quella frase, è nato da quel titolo e quest’epigrafe. Bourgeois si è occupata di genitorialità mostruosa, usa i ragni per rappresentare la maternità; in una serie di dipinti chiamata Femme Maison ogni tela raffigura una donna nuda che al posto della testa o di altre parti del corpo ha un palazzo. Insomma, un legame fra la sua opera e i contenuti del romanzo c’è. Ma l’incomunicabilità resta il tema principale.
Quando il protagonista elenca le “colpe” di lei, dice: «la più grave è la bugia».
Sì, esatto. È un libro sulle cose che finiscono ma è soprattutto un libro sulle cose che non si riescono a dire o spiegare. All’inizio era più complesso, più chiuso in sé stesso. Ricordo che una persona dopo aver letto una delle primissime stesure del romanzo mi disse: «il fatto che è un libro sull’incomunicabilità non significa che non deve comunicare». Nelle versioni precedenti lei era troppo repentina nel dare fuoco alla casa. Ora è un po’ più lento quel processo. Non volevo che il lettore potesse pensare che Margherita ha quella reazione perché legge i suoi referti medici; per me non è mai stato quello il punto. Niente affatto. Il motivo per cui lei se ne va è che ha un problema con lui, non con il proprio corpo. Per me il senso di questo libro doveva essere nell’incomunicabilità, nell’assenza di una spiegazione finale; mi interessava che il finale arrivasse come arriva ora. Come spero che arrivi ora. Ma scrivere di incomunicabilità quando scrivere è comunicare qualcosa non è facilissimo.
A un certo punto, nel tuo romanzo, ci sono delle storie che il padre del narratore di Acqua racconta al figlio per fargli mangiare le carote. Domanda banale, retorica, financo idiota: a cosa servono le storie?
Non direi a far mangiare cose che non ti piacciono. A cosa servono? Boh. Mi piace la domanda perché mi fa venire in mente solo soluzioni che escluderei. Non direi che lo scopo è farti fare qualcosa che non ti piace. Non è neanche, secondo me, l’escapismo: farti distrarre in un mondo altro. Non è insegnarti qualcosa. Credo sia trovare dei significati diversi alle cose che fai e che vedi. Non è escapismo, è consentirti di reinterpretare la tua vita reale. È una via di mezzo, è uscire per poter tornare. E significa anche essere accolti da qualcosa.
Anche le storie più spaventose hanno costruito un mondo in cui tu puoi stare
Raccontare una storia è un modo per costruire una casa, per creare una rete di comunicazione, immaginazione, condivisione e protezione. Anche le storie più spaventose hanno costruito un mondo in cui tu puoi stare. E tu ci puoi stare. Il fatto che poi l’utilità sia consentirti di ritornare al presente e avere strumenti diversi, e riconoscerlo come qualcosa di diverso, è possibile perché prima hai avuto un posto sicuro.

Le case (Fenouillet) (1898-1899) di Henri Matisse, The Barnes Foundation, Philadelphia
«I giardinieri avevano dovuto sacrificare qualche albero (spezzato, crollato, male attecchito) e qualche collaboratore (spezzato, schiacciato, ferito)»: c’è una violenza ironica e per certi versi ingenua, quasi come se ci fosse un gusto fiabesco della violenza, nel tuo romanzo. Si avverte la capacità di intuire il lato comico di un atto violento. Qual è il tuo rapporto con la violenza nelle storie?
In generale quello che mi piace della violenza è che mi sembra consentire di sviluppare le storie in modo credibile. Credo che la violenza sia molto più quotidiana di quello che ci diciamo. La violenza, le crudeltà, le esplosioni d’ira, il voler rompere le cose, tutto questo fa parte delle persone e delle loro vite ed è molto presente.
Esistono genitori che torturano i propri figli. Esistono genitori che violentano i propri figli, che li lasciano affogare nel vomito, che li lasciano morire di fame, che li soffocano, che li strangolano, che li uccidono.
Esistono genitori che per proteggere i propri figli li opprimono, li segregano, scelgono le loro scuole, le loro compagnie, i loro desideri e i loro destini. Ne fanno adulti a volte infelici, altre volte mediocri; più spesso, mediocri e infelici. Altre volte ancora non ne fanno adulti.
E poi mi piace ciò che la violenza mi consente di fare a livello di stile. Determinati suoni e strutture sintattiche mi sembrano funzionare meglio con temi violenti. Forse mi piace proprio un discorso di potenza e potere, non dico in senso politico, intendo in senso materiale, fisico. La violenza è inscritta in un altro ordine di potere ed è prevaricante su qualsiasi cosa, non c’è niente da contrastare. È violento anche il fuoco.
È primitivo.
Sì, esatto. Non è violento il gesto di lei che dà fuoco alla casa, è violento il fatto che una volta che l’incendio è partito il fuoco brucia e tu non ci puoi fare niente. È quello che mi piace. Il lato arcaico, primitivo della violenza. È mitico, biblico. E infatti quelle sono storie violentissime e fondative.
Ultima domanda. Non ti chiederò se o cosa stai scrivendo, ma: ora che hai scritto e pubblicato questa storia, ora che non hai le pressioni che derivano dall’avere una storia che vuoi raccontare, ora che l’hai messa da parte, che scrittrice senti di voler essere in futuro?
Vorrei distaccarmi di più dalla realtà e dal contemporaneo. Questa è l’unica certezza che ho: scrivere storie un po’ meno quotidiane. Non so se voglio dare più spazio alla voce dei racconti o a quella del romanzo. Forse vorrei essere di più l’Eleonora dei racconti che stanno dentro al romanzo. Le voci narranti particolari continuano ad affascinarmi, ma non penso ci sarà un altro «noi».
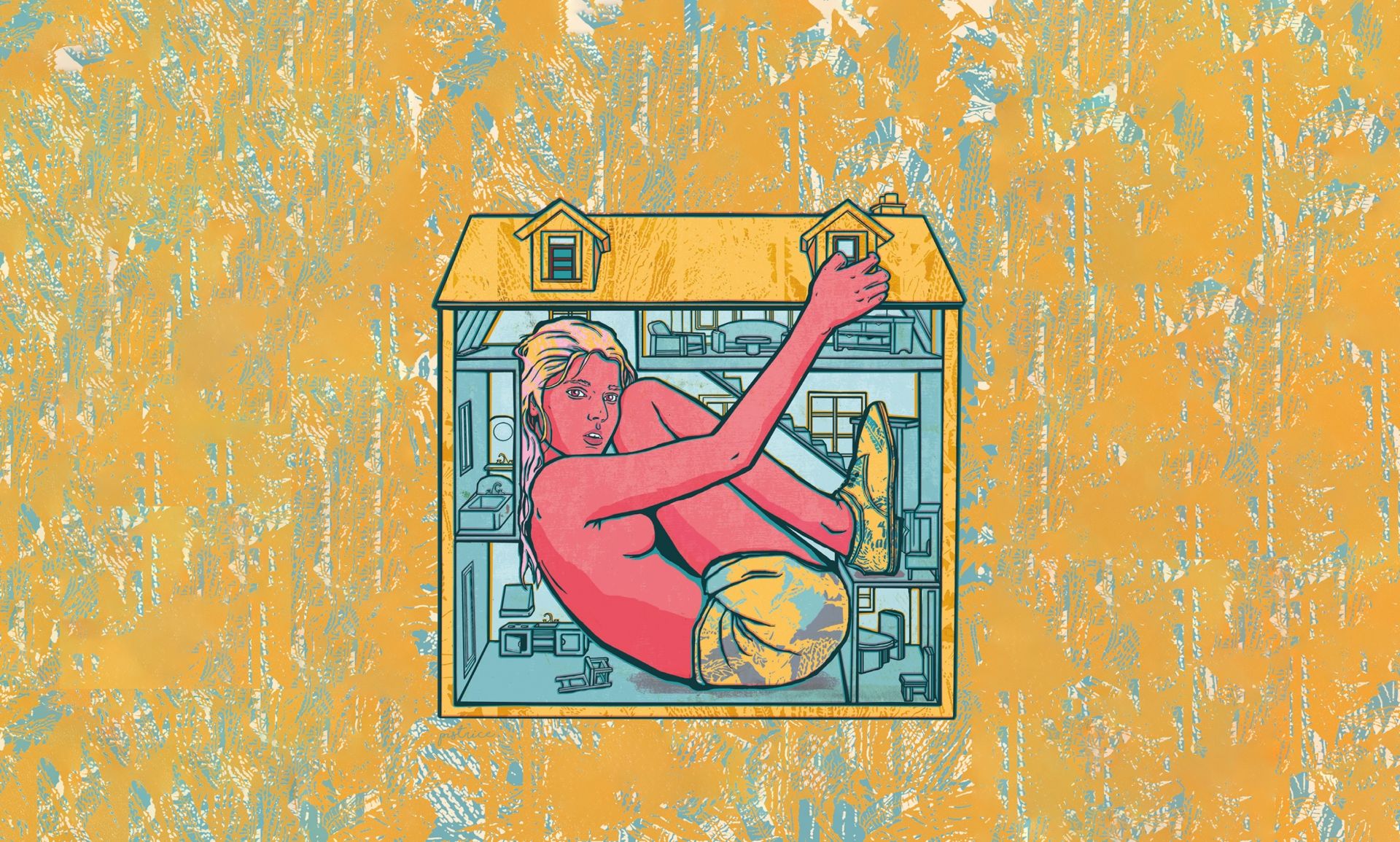
Commenta