Quella casa nello spazio
Guardare la Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale con il romanzo Orbital, vincitore del Booker Prize 2024
A gennaio 2025 l’agenzia spaziale russa Roscosmos ha ufficialmente accettato il piano della Nasa per deorbitare la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel 2030 e riportarla a terra. Yuri Borisov, ex Ceo di Roscosmos (sostituito a febbraio da Dmitry Bakanov, “l’Elon Musk della Federazione Russa”), ha detto che la Stazione non merita ulteriori manutenzioni, date le perdite e i malfunzionamenti degli ultimi anni: «I nostri cosmonauti devono dedicare sempre più tempo alla riparazione delle attrezzature e sempre meno alla conduzione di esperimenti». Forse c’è stata una stretta di mano tra Borisov e il suo corrispettivo americano, forse solo qualche scialbo messaggio diplomatico. E probabilmente è vero: questa casa vecchia ha troppe falle. Dalla prima volta in cui ha ospitato tre astronauti (novembre 2000, 136 giorni, Sergej Krikalëv, William Shepherd e Jurij Pavlovič Gidzenko), l’ISS ha continuato a ruotare attorno al nostro pianeta senza mai fermarsi. Sono passati governi, crisi, guerre, pandemie, ma la Stazione è rimasta in orbita, a ogni giro meno prestante. E nel 2030 rientrerà, scortata dallo US deorbit vehicle di SpaceX, bruciando a contatto con l’atmosfera. La nostra unica casa nello spazio che torna a terra in fiamme.
Sono passati governi, crisi, guerre, pandemie, ma la Stazione è rimasta in orbita. Nel 2030 rientrerà
Orbital di Samantha Harvey, romanzo vincitore del Booker Prize del 2024 pubblicato in Italia da NN editore nella traduzione di Gioia Guerzoni, nasce dalla stessa forma di nostalgia, la nostalgia per qualcosa che esiste ancora ma ha i giorni contati. Il futuro è già passato, l’antico sogno di studiare lo spazio dalla ISS verrà superato presto da altri traguardi – un nuovo allunaggio, Marte, chissà cos’altro – e non resta che raccontarlo, ricordarlo, scomporlo nelle diverse prospettive.
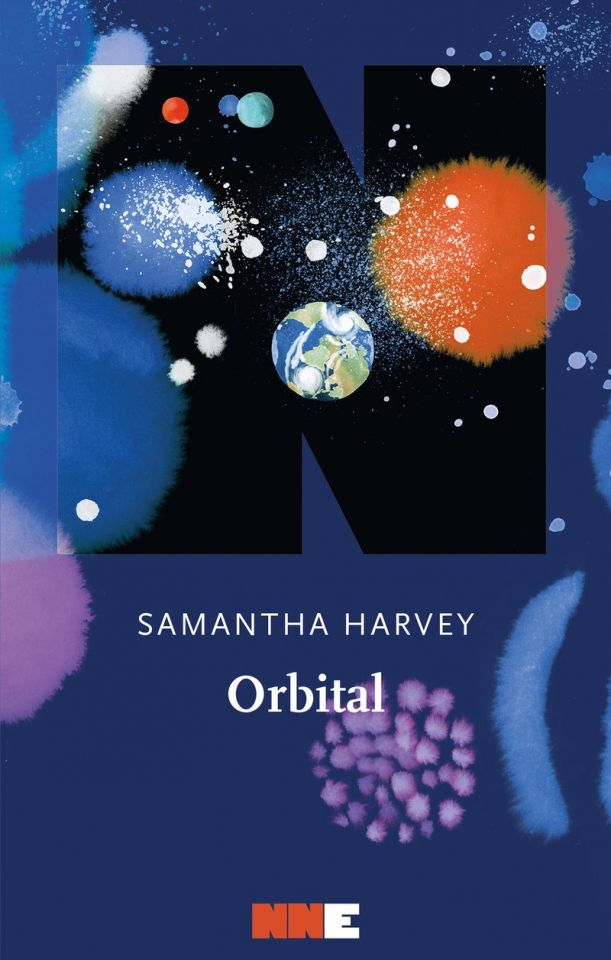 L’autrice britannica, con una formazione tra filosofia e scrittura creativa (insegna scrittura alla Bath Spa University), si è già confrontata nelle sue prime quattro opere con romanzi in cui il punto di vista giocava un ruolo fondamentale: The Wilderness (2008), il suo esordio, è la storia di Jake, un architetto malato di Alzheimer che deve fare i conti con una memoria che si disgrega, così come fa il testo, che passa dalla omogeneità alla frammentazione, dalla prima persona alla terza, quando il protagonista non sa più chi è; Vento dell’ovest (2018), il suo penultimo libro, portato in Italia da Neri Pozza nel 2020, è un thriller di ambientazione medievale che si muove su una sorta di anticlimax, dalla conclusione dell’indagine sull’omicidio (o suicidio) di un abitante del villaggio di Oakham al giorno della sua morte. Harvey, più che lo sviluppo degli eventi, racconta il modo in cui gli eventi vengono percepiti, attraverso il punto di osservazione di uno o più personaggi. E forse è per questo motivo che in Orbital non succede quasi nulla, eppure funziona.
L’autrice britannica, con una formazione tra filosofia e scrittura creativa (insegna scrittura alla Bath Spa University), si è già confrontata nelle sue prime quattro opere con romanzi in cui il punto di vista giocava un ruolo fondamentale: The Wilderness (2008), il suo esordio, è la storia di Jake, un architetto malato di Alzheimer che deve fare i conti con una memoria che si disgrega, così come fa il testo, che passa dalla omogeneità alla frammentazione, dalla prima persona alla terza, quando il protagonista non sa più chi è; Vento dell’ovest (2018), il suo penultimo libro, portato in Italia da Neri Pozza nel 2020, è un thriller di ambientazione medievale che si muove su una sorta di anticlimax, dalla conclusione dell’indagine sull’omicidio (o suicidio) di un abitante del villaggio di Oakham al giorno della sua morte. Harvey, più che lo sviluppo degli eventi, racconta il modo in cui gli eventi vengono percepiti, attraverso il punto di osservazione di uno o più personaggi. E forse è per questo motivo che in Orbital non succede quasi nulla, eppure funziona.
Harvey, più che lo sviluppo degli eventi, racconta il modo in cui gli eventi vengono percepiti
L’autrice sceglie di non puntare sull’ultima ipotetica missione della ISS – e costruire un intreccio più romanzesco – ma di raccontare una delle tante missioni che potrebbero passare tra i moduli della Stazione, calando la storia in un movimento antinarrativo. I personaggi a bordo sono sei: due cosmonauti russi (Roman e Anton) e quattro astronauti, due uomini e due donne (Shaun, americano; Pietro, italiano; Chie, giapponese; Nell, inglese). Alcuni di loro sono arrivati prima degli altri, ognuno è lì per svolgere un compito specifico (chi studia cellule per trovare nuove cure, chi testa la resistenza dei topi a microgravità, chi coltiva le piante per capire come potrebbero crescere nello spazio) ma tutti condividono un’esperienza fuori dal comune, ad oggi accessibile solo a pochissimi professionisti, a Katy Perry o a chiunque sia tanto ricco da potersi imbarcare in una scampagnata spaziale a bordo di un razzo Blue Origin. Il romanzo segue lo sviluppo di una singola giornata vissuta dai sei astronauti, scandita dai giri orbitali che l’ISS compie intorno alla Terra (sedici: con sedici albe e sedici tramonti). A ogni rotazione le vite dei protagonisti possono cambiare – Chie subisce un lutto, Roman riesce a mettersi in contatto con uno sconosciuto sulla Terra per combattere la solitudine – o restare identiche a loro stesse, non è importante, perché il vero soggetto del romanzo è lo sguardo.
_-_earth_observation_taken_during_a_night_pass_of_spain_and_italy_by_the_expedition_43_crew_aboard_the_international_space_station.jpg)
Francia e Italia viste dalla Expedition 43 sulla Stazione Spaziale Internazionale (NASA)
Prospettiva uno. Guardare la Terra dalla ISS significa ribaltare il punto di vista a cui siamo abituati – non più dal basso in alto, ma dall’alto in basso – e ripensare a cascata tutto ciò che il nostro pianeta contiene. È un po’ come tornare nella casa d’infanzia dopo averla abbandonata, ricordata, interiorizzata. I particolari che prima ci sfuggivano – una piccola crepa nel muro, la forma strana di alcuni mobili, il dislocamento delle stanze – saltano all’occhio quando la distanza di tempo e spazio ci permette di allontanare lo sguardo e ricomprendere tutto. Viaggiando sulla Stazione Spaziale Internazionale i protagonisti si rendono conto in modo più profondo di essere nati su un pianeta, osservano gli stessi fenomeni atmosferici che dalla crosta terrestre sembrano occasionali, instabili, umorali, con un occhio diverso – per farsi un’idea, qui la diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale, attiva 24 ore su 24 (mentre scrivo siamo 87 spettatori). Durante questa lunga rotazione i tifoni si alternano alle spianate di sole, le scariche di fulmini inseguono nuvole stanche e rarefatte. E considerazioni che in altri testi risulterebbero retoriche, in Orbital acquisiscono senso e profondità: i confini tra Stati, visti dallo spazio, non esistono, e le guerre per quei confini perdono senso.
Durante l’addestramento erano stati avvertiti di cosa sarebbe successo esponendosi ripetutamente a questa Terra priva di interruzioni. Vedrete la sua pienezza, l’assenza di confini se non la linea tra mare e terraferma, dicevano. Non vedrete paesi, solo una sfera rotante che non conosce possibilità di divisioni, e tantomeno di guerre. E vi sentirete tirati in due direzioni simultaneamente. Euforia, ansia, estasi, depressione, tenerezza, rabbia, speranza, disperazione. Perché ovviamente sapete che le guerre abbondano e che la gente uccide e muore per i confini. Mentre quassù ci può essere il lieve e distante incresparsi della terra che suggerisce una catena montuosa o una vena che fa pensare a un grande fiume, ma nient’altro. Non ci sono muri o barriere – e nemmeno tribù, guerre o corruzione, né particolari motivi per cui aver paura.
_-_three_of_the_six_crew_members_aboard_the_international_space_station_peek_out_of_their_sleeping_quarters_on_christmas_morning_.jpg)
Gli astronauti Paolo Nespoli, Scott Kelly e Catherine Coleman festeggiano il Natale del 2010 durante la Expedition 26 (NASA)
Prospettiva due. Se il panorama è la Terra vista dallo spazio, il punto di vista del romanzo resta personale, quello di sei astronauti che guardando la Terra guardano loro stessi. Orbital è una riflessione sulla nostra specie, sui ricordi che conserviamo quando siamo lontani da casa, sulle motivazioni che ci spingono ad attraversare lo spazio quando abbiamo un pianeta fatto per ospitarci. Cosa ci attrae verso una frontiera sempre più lontana, da dove viene la sete di conquista e scoperta che muove l’umanità. Pietro, l’astronauta italiano, ricorda nel romanzo una conversazione che ha avuto con la figlia poco prima di partire, sul ruolo ambivalente della tecnologia, strumento di distruzione e motore di avventure.
Prima di lasciare la Terra, sua figlia, ormai adolescente, gli aveva chiesto, pensi che il progresso sia bello? Sì, certo, aveva risposto subito lui, senza rifletterci. Mio dio se è bello. E allora la bomba atomica e le stelle finte che metteranno nello spazio con i loghi aziendali, e i palazzi che vogliono piazzare sulla Luna, stampati in 3D con la sua polvere? Vogliamo davvero dei palazzi sulla Luna? Io adoro la Luna così com’è, ha detto lei. Sì, certo, ha risposto lui, anch’io, ma tutte queste cose sono belle perché la loro bellezza non deriva dal fatto di essere buone o meno, non hai chiesto se il progresso è una buona cosa, e una persona non è bella perché è buona, è bella perché è viva, come un bambino. Viva e curiosa e inquieta. Non importa se è buona. Le persone sono belle perché hanno quella luce negli occhi. Certo, a volte sono distruttive, egoiste, a volte ti feriscono, ma rimangono belle perché sono vive. E il progresso è così, vivo per natura.
E ancora: Orbital analizza e scompone la prospettiva antropocentrica, questa forma di narcisismo collettivo, per capire perché ci sentiamo il centro dell’universo quando tutte le prove scientifiche dimostrano il contrario. Shaun se lo chiede mentre guarda una riproduzione in formato cartolina del quadro Las Meninas di Diego Velázquez, che gli è stata regalata dalla sua compagna in ricordo del loro primo incontro al liceo. L’opera è calzante perché è un dipinto nel dipinto, un quadro sulle prospettive.
 Velázquez, l’artista, è nel quadro, al cavalletto, a dipingere un quadro, e quello che sta dipingendo sono il re e la regina, ma loro sono fuori dal quadro, dove siamo noi che guardiamo dentro, e sappiamo che sono lì solo perché vediamo il loro riflesso in uno specchio proprio di fronte a noi. Il re e la regina guardano quello che stiamo guardando noi, la figlia e le sue damigelle, che poi è il titolo del dipinto: Las Meninas, le damigelle. E allora qual è il vero soggetto di questo quadro: il re e la regina (che l’artista sta ritraendo e i cui volti bianchi riflessi, anche se piccoli, sono al centro dello sfondo), la loro figlia (che è la protagonista in mezzo alle altre, così bionda e luminosa nella penombra), le sue damigelle (e i nani e gli accompagnatori e il cane), l’uomo dall’aria furtiva che sembra portare un messaggio e si intravede in fondo, sulla porta, Velázquez (la cui presenza come pittore è dichiarata dal fatto che si trova nel quadro, al cavalletto, a dipingere un ritratto del re e della regina o forse proprio Las Meninas), o siamo noi, gli spettatori, che occupiamo la stessa posizione del re e della regina, che guardiamo dentro e che siamo guardati sia da Velázquez sia dalla principessa bambina e, di riflesso, dal re e dalla regina? O il soggetto è l’arte stessa (che è un insieme di illusioni e trucchi e artifici all’interno della vita) o la vita stessa (che è un insieme di illusioni e trucchi e artifici all’interno di una coscienza che sta cercando di capire la vita tramite percezioni e sogni e arte)?
Velázquez, l’artista, è nel quadro, al cavalletto, a dipingere un quadro, e quello che sta dipingendo sono il re e la regina, ma loro sono fuori dal quadro, dove siamo noi che guardiamo dentro, e sappiamo che sono lì solo perché vediamo il loro riflesso in uno specchio proprio di fronte a noi. Il re e la regina guardano quello che stiamo guardando noi, la figlia e le sue damigelle, che poi è il titolo del dipinto: Las Meninas, le damigelle. E allora qual è il vero soggetto di questo quadro: il re e la regina (che l’artista sta ritraendo e i cui volti bianchi riflessi, anche se piccoli, sono al centro dello sfondo), la loro figlia (che è la protagonista in mezzo alle altre, così bionda e luminosa nella penombra), le sue damigelle (e i nani e gli accompagnatori e il cane), l’uomo dall’aria furtiva che sembra portare un messaggio e si intravede in fondo, sulla porta, Velázquez (la cui presenza come pittore è dichiarata dal fatto che si trova nel quadro, al cavalletto, a dipingere un ritratto del re e della regina o forse proprio Las Meninas), o siamo noi, gli spettatori, che occupiamo la stessa posizione del re e della regina, che guardiamo dentro e che siamo guardati sia da Velázquez sia dalla principessa bambina e, di riflesso, dal re e dalla regina? O il soggetto è l’arte stessa (che è un insieme di illusioni e trucchi e artifici all’interno della vita) o la vita stessa (che è un insieme di illusioni e trucchi e artifici all’interno di una coscienza che sta cercando di capire la vita tramite percezioni e sogni e arte)?
Oppure – aveva detto l’insegnante – è solo un dipinto sul nulla? Soltanto una stanza con dentro della gente e uno specchio?
In questo gioco di proiezioni e specchi l’essere umano può osservare solo sé stesso, perché si sente isolato nell’universo. Il narcisismo è anche solitudine («cosa possiamo fare nella nostra solitudine assoluta se non guardare noi stessi?»), uno sguardo rivolto all’interno perché fuori dai confini terrestri c’è l’ignoto. A questo punto però Harvey fa slittare di nuovo il punto di vista. Il quadro di Velázquez nasconde un particolare: tra tutti i soggetti ritratti c’è un cane, seduto tra le damigelle, che è l’unico essere vivente dell’opera a tenere gli occhi chiusi. In un dipinto basato sui punti di vista, sulla centralità dello sguardo, questo cane che non guarda nessuno sembra l’unico soggetto in pace con sé stesso. Mentre gli altri sono impegnati a mantenere le loro pose, a trasmettere una certa altezzosità tra polsini e gorgiere, a fare di tutto pur di non sembrare degli animali, l’animale è il solo a non risultare ridicolo «o intrappolato in una matrice di vanità. L’unica creatura nel quadro che si possa definire vagamente libera». Il cane è sereno perché non cerca altri punti di vista, non si deve specchiare negli occhi degli altri per capire chi è.
_-_esa_astronaut_luca_parmitano_is_pictured_tethered_to_the_international_space_station_.jpg)
L’astronauta dell’ESA Luca Parmitano legato alla ISS completa le riparazioni termiche dell'Alpha Magnetic Spectrometer, un rilevatore di materia oscura e antimateria, in un’uscita spaziale durata 6 ore e 16 minuti durante l’Expedition 61 (NASA)
Prospettiva tre: lo spazio, l’ultima frontiera, quella senza confini. Quando gli astronauti escono dalla ISS per svolgere missioni che durano ore solo per aggiustare una piccola avaria, sentono il fascino del cosmo, sono sedotti da questa cosa smisurata e a bassa densità di particelle che è lo spazio. Non riescono a dire perché, ma sentono che è così. Nell, l’astronauta inglese, racconta di non aver provato paura, ansia o pressione fuori dalla Stazione, ma un’attrazione inspiegabile verso l’ignoto: «aveva solo voglia – se provava un qualche desiderio quando era là fuori – di andare alla deriva in quel nulla e che il suo cavo si srotolasse per migliaia di chilometri». Ed è anche il motivo per cui Orbital colpisce: è un romanzo a bassa densità di avvenimenti che ci mette di fronte a domande smisurate, che attrae come attrae l’ignoto.
_---_the_last_rays_of_an_orbital_sunset_fade_below_earths_horizon_illuminating_the_atmosphere_in_this_photograph_from_the_international_space_station_.jpg)
Gli ultimi raggi di un tramonto orbitale fotografati dalla Stazione Spaziale Internazionale nel 2024 (NASA)
In copertina la Stazione Spaziale Internazionale fotografata da una navicella Soyuz (NASA/Roscosmos)
_-_the_international_space_station_phot_._by_expedition_56_crew_members_from_a_soyuz_spacecraft_after_undocking_(nasa-roscosmos)_.jpg)
Commenta