Poesie di identità e resistenza
La consapevolezza di un paese nei versi della raccolta Poeti d’Ucraina, tra dissidenza anni Sessanta e invasione russa
Un giorno, in quell’età sospesa tra la fine dell’adolescenza e l’inizio della vita adulta, ciascuno di noi è salito su un treno diretto verso una meta che avevamo scelto per definire la nostra identità. Eravamo inquieti, e attorno a noi il paesaggio sembrava mostrarci tutto ciò che volevamo conservare e tutto ciò che volevamo lasciarci alle spalle. Così fu anche per il poeta ucraino Serhij Žadan, classe 1974, in un momento fatidico dei selvaggi anni Novanta, quando c’era un intero paese da reinventare dopo la fine dell’epoca sovietica.
Ricordo le voci,
le cose intrecciate in stazione,
il crescente crepuscolo
tra forni e buffet.
Il sole come il succo di limone
che imbratta tutti i miei vestiti
e brucia come benzina
tra le lancette della torre.
Le bocche sanno di amaro,
di amanti e cacciatori
che condividono zucchero e tabacco
come i ladri che vanno in prigione.
Il vecchio tossico che cuce
galloni tolti dal cappotto,
le nubi calde lungo i fiumi
che nuotano verso la Crimea.
Mi volto repentino indietro
tra il silenzio e il tuono,
mi torni improvvisa in mente
mentre mi dico da solo
che questo maturare della sorte
lascia tutto quanto al puro caso,
il fiore nero detto anche alcol
che sboccia sugli spigoli dorsali,
che ogni qualunque guardiano
dei treni merce in silenzio
verrà soltanto ricordato
dai suoi colleghi di stazione,
che il momento della mia fine
verrà con le folate di maree,
che assorderanno il silenzio
coi fischi delle locomotive,
che poi i carichi postali
stazioneranno nelle sale
insanguinati, affilati
come i coltelli,
come il pepe,
come la pece sulle traverse.
Siamo nel Luhans’k, in quel Donbass che abbiamo tragicamente imparato a conoscere, ma se i fiumi non nuotassero «verso la Crimea» potremmo essere in una qualunque delle remote province italiane da cui provengono tutti i veri irrequieti; ci siamo noi su quel binario, a riprova che la vera letteratura sopravvive anche alle traduzioni, alle distanze spazio-temporali, ai singoli riferimenti che non capiamo.
Questo spaccato di mondo è solo una delle gemme che tempestano Poeti d’Ucraina (Mondadori, 2022), ricca antologia di 34 autori e 88 poesie – con traduzione e testo ucraino e russo a fronte – curata da Alessandro Achilli e Yaryna Grusha Possamai (anche autrice della guida sentimentale Dimensione Kyiv. Viaggio letterario in una città ferita nelle voci di classici e contemporanei, uscita per Rizzoli). Il volume, pubblicato nell’estate 2022, fotografa mirabilmente la storia letteraria dell’Ucraina dal secondo dopoguerra al maggio 2022: che il libro sia una risposta politica all’aggressione putiniana è un fatto ovvio e certo non sminuisce il valore artistico dell’operazione, tanto più necessaria di fronte all’assoluta ignoranza della cultura ucraina nel nostro paese. Basti un dato su tutti: come ha evidenziato Ludovico Zanette sul canale dell’associazione Liberi oltre, quasi nessuno degli autori antologizzati ha una scheda in Wikipedia Italia, tanto che per le informazioni di base occorre rivolgersi alle pagine in varie lingue straniere.

Vasyl’ Stus, il secondo da sinistra, nella casa di famiglia con alcuni amici
Il libro si apre con una sezione dedicata a Vasyl’ Stus, una delle voci più importanti della dissidenza negli anni Sessanta e Settanta. Più volte incarcerato, fintamente difeso da quel Viktor Medvedčuk che oggi è fra gli oligarchi più vicini a Putin, morì nel 1985 all’interno del gulag russo Perm-36, in barba a qualunque perestrojka. «Chi sei? Un vivo o un morto?» si chiede il poeta in Cento specchi proiettati su di me, e subito la mente corre alla Waste Land di Thomas S. Eliot («Are you alive, or not?»), emblema di quel modernismo internazionale represso da Stalin in nome del realismo socialista. L’interrogativo di Stus è una radiografia della sua condizione di perseguitato, «al di là / della paura e della speranza», ma anche un monito per i suoi eredi della Scuola di Kyjiv, che a partire dagli anni Settanta ripiega su una poetica intimista ben rappresentata dalla toccante A lungo tessemmo di Mychajlo Hryhoriv.
Circondati
dai primi germogli
di muschio
riempivamo
il vuoto senza voce
convincendo
noi stessi
ogni volta
di nuovo
come se fossimo proprio reali
sulla punta della fiamma di candela
dove sempre
c’è solo
sempre la candela
ma
ancora spostammo
alcune croci
alcuni alberi
da ambo i lati del canale
da cui si incanalava
l’acqua
L’ostentata distanza di questi autori dalle fanfare della propaganda evidenzia le prime crepe nel regime, ma sono i ‘poeti degli anni Ottanta’ (visimdesjatnyky) ad aprire le falle più profonde nella diga sovietica: Hryc’ko Čubaj distrugge il realismo socialista con la sua esibita sensualità («Alle tue labbra manca meno di un respiro / alle tue labbra manca meno di un passo. / La meraviglia ricama le tue pupille / e negli occhi hai un blu immenso»), mentre Oksana Zabužko descrive il ritardo abissale dell’URSS rispetto all’Occidente («Dal Novecento, come da un pallone bucato, / esce l’aria fischiando, / si gonfia silente il secolo che viene / ma non per noi, / non su di noi») e la desolazione post-nucleare di Černobyl’ («Sembra l’alba, / la luce piegata come un lenzuolo. / I mozziconi nel posacenere / Un fiore chiuso nel vaso»).

Il popolo ucraino si riunisce in Piazza Indipendenza a Kyjiv negli anni ’90 per celebrare l’indipendenza dall’Unione Sovietica. Foto di M. Yakovenko e V. Biletskyi
Si arriva così al marzo 1990, quando i cittadini di Kyjiv, sull’onda della caduta del Muro di Berlino, reclamano libertà e democrazia in piazza Rivoluzione d’Ottobre: un anno dopo, a seguito della ‘Rivoluzione sul granito’, lo stesso luogo diventa Piazza Indipendenza (Majdan Nezaležnosti), simbolo della nuova Ucraina nata dallo scioglimento dell’URSS. È un momento felice, che Attyla Mohyl’nyi ricorda come «il tempo delle canzoni italiane. / il tempo del trallallero trallallà. / Il tempo del mare e quella ragazza / bella come il sole / Le montagne di neve. Il cielo di cristallo. / Mare. Marina. Amore», ma è anche l’inizio di trasformazioni radicali e drammatiche, con genti che si spostano e terre che si spopolano, riflesse nella geografia interiore di Anatolij Dnistrovyj: «le città abbandonate / le chiamo una ad una / […] lo vedo quello che significano / lo vedo quello che continuo a perdere / non sentire / la loro aria che sa di metano / di lillà che fiorisce in maggio / non sentire / quello che da anni mi consuma». E mentre Jurij Andruchovyč racconta l’emigrazione con ironia («Una coppia di immigrati, / pensavano gli italiani. Li vedi subito: / se ne stan zitti a guardar fuori, / ma quando è buio fan finta di dormire. / […] Di noi non gli sfuggiva niente. / Anche quello che non sapremo mai nemmeno noi»), un’intera nazione in cerca di sé stessa trova il suo cantore in quel Serhij Žadan che avevamo lasciato sul binario di una stazione orientale.
In qualche modo sei cresciuto in questa buca tra i paesi,
tra monaci, anarchici e rifugi,
comunità ebraiche, repubbliche,
tenendo la lingua tra i denti per non tremare,
per te il discorso era sempre
come un anticipo all’acquisto
e un vendere il tuo prossimo alla prima asta.
Vuoi strappare le catene che ti han messo
e cambiare l’abito orientale ucraino,
dove vivevi nel disagio,
con le stazioni ucraine erette a Ovest.
E poi, ferito al confine,
tu che dovevi affondare da tempo
tenevi in mente il cielo, che sembrava tanto puro,
e le monete d’oro ben nascoste pesavano sul fondo,
e deragliava il tuo treno oltre i confini del paese.
Era una gara e non una fuga.
Da ambedue i lati i doganieri fermano il treno
e guardano il flusso che ti rimanda indietro,
come una chiesa che guarda a Est.
Sull’onda di questo travaglio interiore, consapevoli che «le rampe / dovranno / elevarsi ancora / alle svolte della storia» (Oleh Kocarev), a novembre 2004 i cittadini di Kyjiv si riversano nel Majdan per protestare contro i brogli elettorali. Da questo evento spartiacque, passato alla storia come ‘Rivoluzione arancione’, nasce l’Ucraina europeista che dieci anni dopo, tra novembre 2013 e febbraio 2014, si ribella al regime del presidente filorusso Janukovyč dando vita alla ‘Rivoluzione della dignità’, partita nuovamente dal Majdan di Kyjiv. La risposta di Putin è in puro stile sovietico: occupazione della Crimea e guerra nel Donbass, due traumi che costringono gli scrittori ucraini di madrelingua russa a ripensare sé stessi. Iryna Cilyk, nel chiedersi «Come ci è successo tutto questo e così fuor di misura?», sceglie di abbandonare la sua lingua natia e di usare l’ucraino per ragioni etiche. Borys Chersons’kyj, fiero della sua multiculturalità, riflette sulle mistificazioni identitarie propagandate da Mosca: «Il mio russo natio con un poco di yiddish, / un qualche ucrainismo, che strano miscuglio. / Un po’ so l’ebraico, ma non da Israele, / non ci so parlare con la gente. / […] ma è torbida quest’acqua, /non ci puoi nuotare, perché è pericoloso, / non ci puoi guardare il cielo mostrandoti pentito, / e il manuale di russo, che ti uccide / il morale, / ma qual è la tua lingua madre, what is your language, / non lo sai più, la guerra ti ha tolto la memoria».
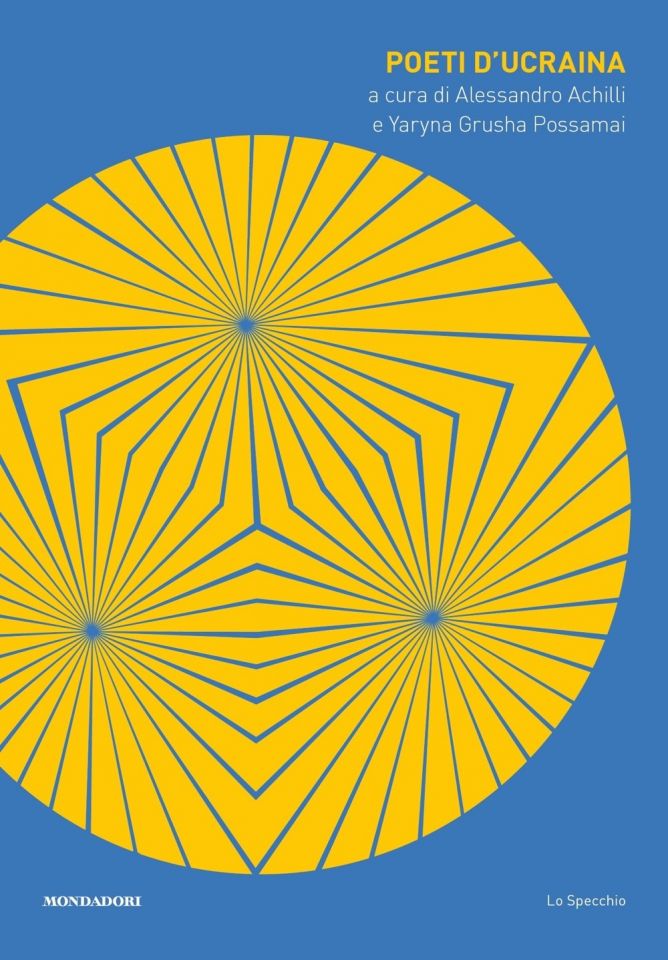 Anastasija Afanas’jeva arriva persino a porsi la più radicale delle domande in una sorta di litania delle località martoriate dal conflitto: «È possibile la poesia dopo / Jasynuvata / Horlivka / Savur-Mohyla / Novoazovs’k / dopo / Krasnyj Luč / Donec’k / Luhans’k / dopo che la gente è divisa / in chi muore e chi riposa / chi ha fame e chi si svaga […] / È possibile / la poesia / quando la storia s’è desta / quando i suoi passi / risvegliano ogni cuore / e non si può parlare d’altro; / ma non si può neanche parlare». La ripresa del noto interrogativo di Adorno sulla possibilità di scrivere versi dopo Auschwitz presuppone naturalmente una risposta positiva: se è vero, come scrive Ija Kiva, che la guerra costringe a «tenere in bocca un ago di silenzio / cucire parole con i fili bianchi / agghiacciarsi inghiottendo la saliva […] imparare a cercare le radici di una vita / che ancora non sa come si chiama», è altrettanto vero che la scrittura è un imperativo morale, una forma di resistenza, una testimonianza di umanità di fronte all’orrore. Ed è con questa consapevolezza che il 24 febbraio 2022, otto anni dopo i fatti di Euromajdan, lo sgomento dell’Ucraina invasa si ritrova concentrato nella poesia di Iryna Šuvalova: «Voi pensavate e noi pensavamo la guerra /non è qui da noi non c’entra con noi non è qui / […] / pensate / che non dormirete e non vi sveglierete / tra le bombe che scoppiano di lì a pochi metri / tra il fuoco e la morte? / pensate. / anche noi fino a ieri / così pensavamo».
Anastasija Afanas’jeva arriva persino a porsi la più radicale delle domande in una sorta di litania delle località martoriate dal conflitto: «È possibile la poesia dopo / Jasynuvata / Horlivka / Savur-Mohyla / Novoazovs’k / dopo / Krasnyj Luč / Donec’k / Luhans’k / dopo che la gente è divisa / in chi muore e chi riposa / chi ha fame e chi si svaga […] / È possibile / la poesia / quando la storia s’è desta / quando i suoi passi / risvegliano ogni cuore / e non si può parlare d’altro; / ma non si può neanche parlare». La ripresa del noto interrogativo di Adorno sulla possibilità di scrivere versi dopo Auschwitz presuppone naturalmente una risposta positiva: se è vero, come scrive Ija Kiva, che la guerra costringe a «tenere in bocca un ago di silenzio / cucire parole con i fili bianchi / agghiacciarsi inghiottendo la saliva […] imparare a cercare le radici di una vita / che ancora non sa come si chiama», è altrettanto vero che la scrittura è un imperativo morale, una forma di resistenza, una testimonianza di umanità di fronte all’orrore. Ed è con questa consapevolezza che il 24 febbraio 2022, otto anni dopo i fatti di Euromajdan, lo sgomento dell’Ucraina invasa si ritrova concentrato nella poesia di Iryna Šuvalova: «Voi pensavate e noi pensavamo la guerra /non è qui da noi non c’entra con noi non è qui / […] / pensate / che non dormirete e non vi sveglierete / tra le bombe che scoppiano di lì a pochi metri / tra il fuoco e la morte? / pensate. / anche noi fino a ieri / così pensavamo».
Se è vero, come scrive Ija Kiva, che la guerra costringe a «tenere in bocca un ago di silenzio», è altrettanto vero che la scrittura è un imperativo morale, una forma di resistenza, una testimonianza di umanità di fronte all’orrore
Molti sono i poeti che in questi dodici mesi si sono ritrovati a imbracciare le armi, come molte le poetesse che svolgono attività di volontariato a sostegno dei rifugiati; nella fuga dai villaggi distrutti narrata da Vitkorija Amelina «la casa diventa / un sasso grigio / una perla / un nocciolo dell’albicocca dell’anno scorso / un vetro che ti taglia la mano per strada / un pezzo di Lego / una conchiglia della Crimea / un seme di girasole / un bottone della divisa di tuo padre», ma se pure «la realtà della guerra / si mangia la punteggiatura […] / come se sulla lingua / fosse caduta una granata», la grande letteratura continua a sopravvivere persino dopo Buča, magari attraverso un post su Facebook o un messaggio inviato ai propri amici dal fronte. E oggi, in tutti coloro che combattono per la libertà, il monito di Serhij Žadan risplende come una stella nel buio.
So solo che questo vale tutti gli sforzi e tutte le pene.
E che abbiamo imparato che niente si fa invano.
E che tutti coloro che non molleranno, avranno
la gioia del mattino e la quiete dorata della notte.
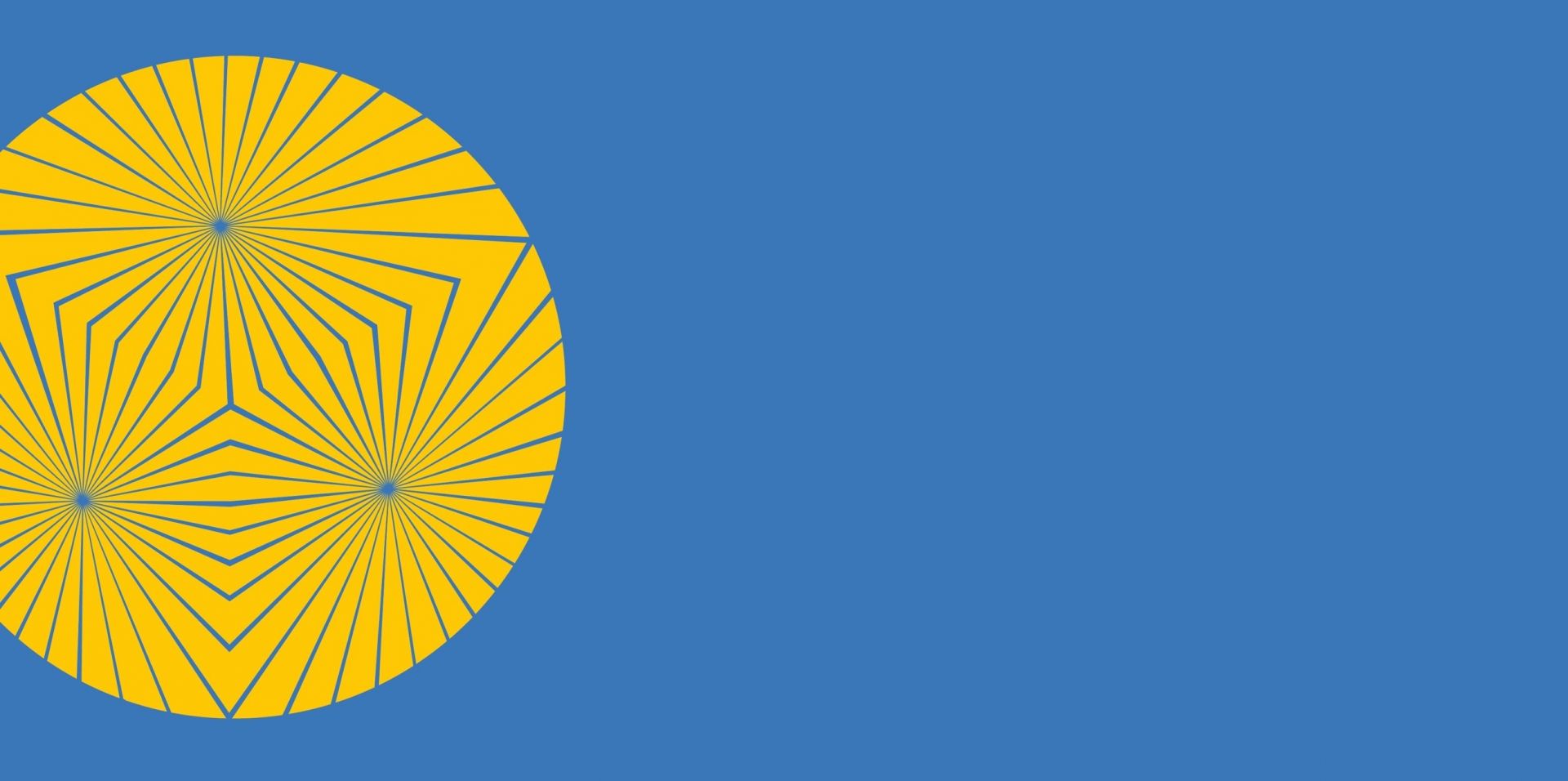
Commenta