Le chimere suburbane di John Cheever
Dentro il racconto | Sulla dualità fra perbenismo wasp e inedita stranezza nei racconti del grande autore statunitense
Quando il suo editore gli propose di pubblicare una raccolta di racconti, Cheever si stupì. «Perché?» chiese. «Quei racconti sono già stati pubblicati». L’edizione che ne risultò, The Stories of John Cheever (1978), divenne una delle raccolte di racconti più vendute di tutti i tempi e valse all’autore un National Book Award e un premio Pulitzer. Questo rafforzò la reputazione vacillante di Cheever, ma soprattutto, come scrisse Robert Morace, «riaccese l’interesse per il racconto da parte di editori e lettori, rendendolo al tempo stesso più appetibile dal punto di vista commerciale e più rispettabile per la critica». Cheever pubblicò 121 racconti sul New Yorker tra il 1935 e il 1981 e alcuni su Esquire, Playboy e altre riviste. Nonostante, per volere esplicito dell'autore, la primissima raccolta di Cheever ne fosse stata esclusa, l'edizione del 1978 ammonta a circa novecento pagine. Il ritmo della prosa alla Hemingway, evidente nei primi racconti, scompare ne La storia di Sutton Place (1946), ma più tardi, ne Il mondo delle mele (1966), il poeta Asa Bascomb recita il proprio credo davanti a una reliquia cristiana, terminando così: «Dio benedica William Faulkner, Scott Fitzgerald, e soprattutto Ernest Hemingway». Aggiungete Čechov e Flaubert e la lista di Bascomb avrebbe potuto essere quella dello stesso Cheever. Oltre ai nomi citati, Elizabeth Hardwick osserva che «l’ambiguo e complesso sottobosco narrativo dei racconti di Cheever richiama l’indole di Melville e Hawthorne».
Prendere atto della stranezza di Cheever dovrebbe essere scontato
Come scrive Blake Bailey nella sua straordinaria biografia, Cheever fece proprie le influenze letterarie al punto che identificarle non aggiungerebbe valore al suo lavoro. Se i meccanismi di tali influenze sono difficili da riconoscere, le ambientazioni dei suoi racconti invece non hanno precedenti: l’autore diventò, per caso, il cronista della Contea di Westchester, nello Stato di New York, proprio nel momento in cui diventava il primo sobborgo su larga scala al mondo. Shady Hill è un posto immaginario comparabile allo Yoknapatawpha di Faulkner o al Wessex di Thomas Hardy. Tuttavia, mentre ci si aspetterebbe che una riflessione sociale si nasconda tra un’aiuola e un praticello curato o che una satira sbuchi dagli impermeabili marroni che affollano la banchina della stazione, in realtà le chimere suburbane di Cheever sono ben più stravaganti di così. Prendere atto della stranezza di Cheever dovrebbe essere scontato, ma a ogni generazione il perbenismo wasp delle sue ambientazioni sembra infestare le sue opere con lo spettro del conservatorismo. Sebbene alcuni dei suoi racconti più famosi siano favole riguardanti radio che trasmettono le conversazioni private dei vicini (Una radio straordinaria) o angeli della morte che percorrono le strade di Manhattan (Ballata), la sensazione generale per un osservatore distratto rimane quella dei pettegolezzi all’ora dei cocktail, dei tradimenti e dei postumi da sbornia la domenica mattina. Certo, tutti questi elementi sono presenti, ma quasi mai sono rappresentati come ci si aspetterebbe. «Non vi è nulla in Updike che non ci sia stato prima in Cheever», scrive Alan Bennett, ma le somiglianze sono solo superficiali: Updike è molto meno anomalo. Ben DeMott definì i racconti di Cheever «densi di inspiegabilità» e lo stesso Cheever in un’intervista per Paris Review disse che la narrativa è «sperimentazione […]. Ogni autore scrive credendo che nessuno prima lo abbia fatto allo stesso modo […]. La forza dei sentimenti e la sveltezza mi sono sempre sembrati estremamente importanti».
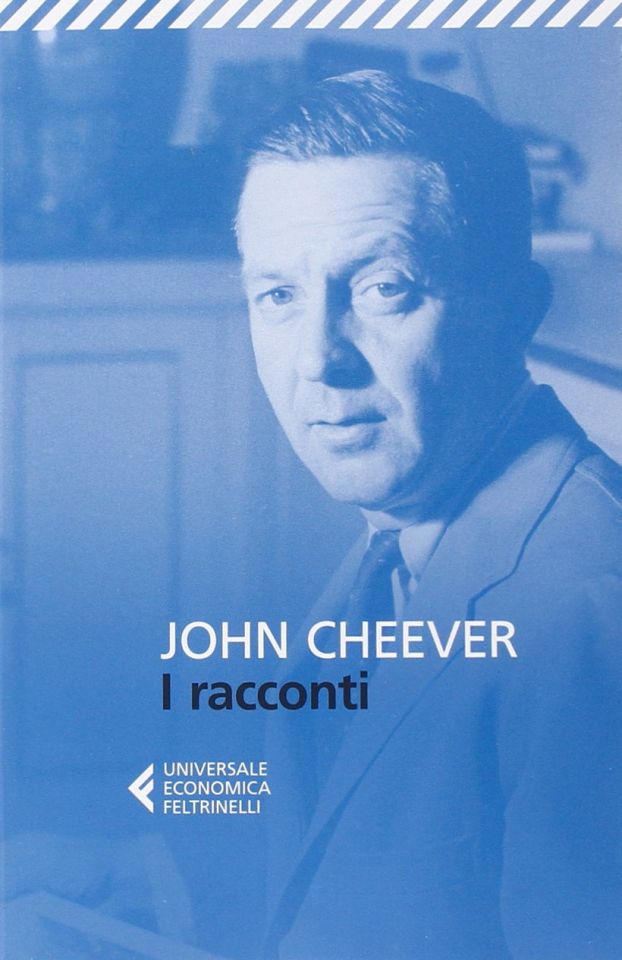
Queste parole descrivono bene le atmosfere create nei suoi racconti più riusciti, che includono, a mio avviso, anche tre dei migliori racconti mai scritti in lingua inglese. Ciascuno di questi – Addio, fratello mio (1950), Il marito di campagna (1954) e Il nuotatore (1964) – condivide anche la profonda dualità di cui lo stesso Cheever era pervaso, come testimoniano i numerosi resoconti sulla sua vita, e che finì per riflettersi nel suo lavoro. In Addio, fratello mio il rampollo di una famiglia del New England elenca le colpe del fratello Lawrence, pecora nera della famiglia, prima di aggredirlo su una spiaggia deserta. Uno dei primi mentori di Cheever trovò la narrazione «pericolosamente incerta». L’autore rispose: «Non vi è alcun fratello, non vi è alcun Lawrence». In un colpo solo semplifica, complica ed espande la storia in molteplici direzioni possibili contemporaneamente. Il nuotatore è il resoconto di un uomo che fa ritorno alla propria casa di Shady Hill attraversando le piscine di amici e vicini e, al tempo stesso, una favola onirica su un uomo privato di ogni cosa. Come ne La metamorfosi di Kafka non troviamo una sola “vera” lettura, bensì due realtà simultanee.
Il nuotatore è una favola onirica su un uomo privato di ogni cosa
Tra questi racconti, però, è Il marito di campagna (1954) a rendere al meglio questa qualità. Edmund White racconta che Hemingway ne rimase così colpito da svegliare la moglie nel cuore della notte per leggerlo ad alta voce. Nel racconto, ogni cosa è duplice. Dopo essere sopravvissuto a un atterraggio di fortuna durante un viaggio di lavoro – dramma che viene totalmente ignorato dalla famiglia – Francis Weed (il cognome denota sia la sua mediocrità che la sua tenacia) torna all’idillio di casa trovando invece un «campo di battaglia». La babysitter è malata e lui si innamora della sua giovane sostituta. A una festa riconosce nella cameriera francese che sta servendo da bere una donna che aveva visto denudare e umiliare in Normandia per aver collaborato con i tedeschi. Shady Hill, la cui ambiguità risiede nel nome, è in bilico tra la fine dell’estate e il freddo autunno: «Tornò a casa in una notte gelida. Nell’aria c’era l’odore pungente del cambiamento». Potrei continuare. Come scrisse Nabokov, il racconto è «davvero un romanzo in miniatura tratteggiato alla perfezione, in cui la coerenza degli intrecci delle tematiche riscatta completamente l’impressione che vi siano troppi avvenimenti».
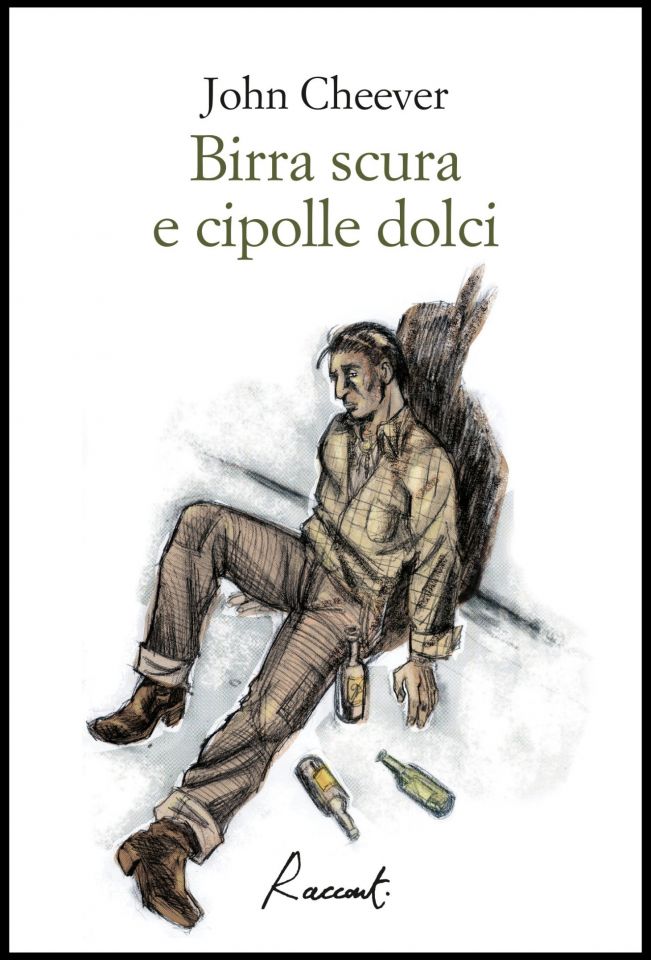
L’ormai famosa conclusione del racconto (qui nella traduzione di Marco Papi tratta da I racconti, Feltrinelli) vede Francis castigato e intento a lavori di falegnameria nel suo scantinato, e ci mostra le bizzarre consuetudini di Shady Hill:
«Vai a casa, Gertrude, vai a casa», sta dicendo la signora Masterson. «Ti ho detto di andare a casa un’ora fa, Gertrude. È passata l’ora di cena, e tua madre sarà preoccupata. Va’ a casa!» Si spalanca d’improvviso una porta sul terrazzo dei Babcock, e ne esce la signora Babcock senza vestiti, inseguita dal marito, anch’egli nudo […]. Corrono attraverso la terrazza ed entrano per la porta della cucina, appassionati e avvenenti come una ninfa e un satiro, quelli che si vedono affrescati su tutti i muri di Venezia […]. L’ultimo ad arrivare è Jupiter, che irrompe tra le piante di pomodoro, stringendo tra le fauci generose i brandelli di una ciabatta. Poi cala l’oscurità, è una notte in cui i re in abiti dorati cavalcano elefanti sopra le montagne.
Questo passaggio, citato frequentemente, conferma l’idea che Cheever, per usare le parole di Philip Roth, sia un «realista incantato». Se isolato dal contesto, però, il passaggio appare molto più strambo di quanto sia. Quasi tutti gli elementi riprendono attentamente frasi o episodi presenti nelle prime pagine del racconto. Ma soprattutto, l’ultima, straordinaria frase richiama e tramuta le parole che un ospite sentimentalista aveva detto ai Weed riguardo la propria moglie alla fine della festa: «È il mio cielo azzurro. Dopo sedici anni, le mordo ancora le spalle. Mi fa sentire come Annibale che valica le Alpi». Rievocata alla fine del racconto, questa smanceria è forse trasformata in un atto di grazia? In una presa in giro? Il fiore all’occhiello della carriera di Cheever è l’abilità di essere al tempo stesso generoso e cinico, riconoscere che l’assurdo e il profondo possono convivere e prenderne atto senza sacrificare né l’uno né l’altro.
Chris Power è un critico letterario e scrittore inglese, autore della raccolta di racconti Mothers (2018) e del romanzo A Lonely Man (2021). Dal 2007 tiene sul Guardian la rubrica monografica dal titolo A brief survey of the short story, di cui questo articolo pubblicato il 16/11/2012 fa parte ► A brief survey of the short story part 45: John Cheever | Traduzione di Giulia Patanè

Commenta