Lacrime di ministro
La riforma Fornero e i suoi fallimenti
Uno dei temi al centro del dibattito sul mercato del lavoro è senza dubbio la riforma Fornero, varata dal governo Monti nel 2012. Tra gli aspetti più rilevanti e controversi della legge si annovera la riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (1970), relativo alle limitazioni al potere di licenziamento.
Nel nostro ordinamento, a parte una residua porzione di rapporti in cui le parti sono libere di recedere, il datore di lavoro può licenziare un addetto solo per motivi riconosciuti dalla legge, altrimenti il licenziamento è illegittimo.
In passato, in caso di licenziamento illegittimo, il giudice ordinava al datore la reintegrazione del lavoratore nel rapporto di lavoro. Con la riforma del 2012, l’ambito della reintegrazione è stato ristretto solo alle ipotesi più gravi di licenziamento ingiustificato. Viceversa, nella maggior parte dei casi il licenziamento, seppure illegittimo, interrompe il rapporto di lavoro, spettando al lavoratore solo un risarcimento dei danni forfetario. In questo modo la disciplina limitativa dei licenziamenti è stata resa più flessibile e meno onerosa per i datori.
Con questa e con simili misure la riforma Fornero si proponeva di rimuovere i supposti privilegi del lavoratori “ipergarantiti”, aprendo le porte dell’occupazione agli outsider, di incentivare una maggiore produttività, di attirare gli investitori stranieri, nonché di ridurre i contenziosi di lavoro. Sfortunatamente le cose non sono andate così.
 L’operato del governo Monti si inserisce in quella linea di tendenza che, a partire dagli anni Ottanta, ha promosso la riduzione del costo del lavoro e delle garanzie per i dipendenti dalla legislazione egualitaria dei decenni precedenti.
L’operato del governo Monti si inserisce in quella linea di tendenza che, a partire dagli anni Ottanta, ha promosso la riduzione del costo del lavoro e delle garanzie per i dipendenti dalla legislazione egualitaria dei decenni precedenti.
Sul piano economico, attraverso l’eliminazione di quegli automatismi che agganciavano l’ammontare del salario all’andamento dell’inflazione, per evitare la perdita di potere d’acquisto delle famiglie, il compito di adeguare le retribuzioni al crescente costo della vita è stato affidato alla contrattazione tra datori e sindacati. Il risultato di questo e di altri fattori è che i salari reali nel nostro Paese sono fermi dai primi anni Novanta – mentre lo stesso non si può dire per i redditi da capitale. In generale, le politiche di penalizzazione del lavoro dipendente perseguite da circa trent’anni, hanno favorito uno spostamento del reddito verso l’alto, mettendo a repentaglio la tenuta della domanda interna. È recente un rapporto della CGIL che documenta come oggi il 10% delle famiglie italiane detenga poco meno della metà della ricchezza totale.
Sul piano normativo, sono state progressivamente ridotte le garanzie che circondano i diversi momenti della vita del rapporto di lavoro, favorendo il ricorso da parte dei datori a lavori a tempo determinato, part time e a forme di impego precarizzate. Curiosamente la produttività del lavoro cresce molto meno ora rispetto al passato delle “garanzie”.
Appartengono alla lotta contro il lavoro subordinato anche le proposte estremiste di un “tecnico” che sogna la riduzione dell’intero impianto protettivo del diritto del lavoro a 15 articoletti, esaltando la necessità di rendere i rapporti di lavoro ancora più flessibili contro i privilegi degli “iper-garantiti”. Si fomenta così la guerra tra la nuova “generazione 1000 euro” e la vecchia “generazione 1200 euro”; mentre il famoso 10%, con le sue ricchezze ereditate con il sudore della fronte e guadagnate con il duro lavoro (degli altri), divertito, si gode lo spettacolo. Un diverso estremismo, non tecnico ma populistico, grida direttamente all’abolizione dei sindacati, per il tramonto definitivo del potere contrattuale dei lavoratori.
La riforma Fornero del 2012 si inserisce pienamente nel filone delle politiche conservatrici. Assai poco sorprendentemente, essa non consegue nessuno degli scopi che si era prefissata.
 Il depotenziamento dell’articolo 18 non ha creato nessun nuovo posto di lavoro: ha solo facilitato i licenziamenti. L’aumento della disoccupazione è continuato, forse facilitato da un articolo 18 più flessibile. La spirale recessiva continua pertanto ad aggravarsi, svenando ulteriormente le casse dello Stato per gli interventi a favore dei disoccupati (cassa integrazione, indennità di mobilità). Le cifre delle integrazioni salariali sembrano vanificare gli sforzi dei tagli lineari eseguiti in nome dell'austerità. Inoltre, i licenziamenti continuano a ingolfare le aule di tribunale. Il rischio è che la già drammatica situazione della giustizia civile si deteriori ancora di più con un regime di “licenziamenti facili”. Infine, i dati sugli investimenti stranieri in Italia non sono ancora disponibili. Tuttavia, il fatto che le remore degli operatori stranieri (e italiani) dipendano più che altro dai tempi della giustizia, dalla criminalità e dal peso della burocrazia ci fanno immaginare l’impatto minimo che la riforma dell’articolo 18 avrà anche nell’attirare gli investimenti.
Il depotenziamento dell’articolo 18 non ha creato nessun nuovo posto di lavoro: ha solo facilitato i licenziamenti. L’aumento della disoccupazione è continuato, forse facilitato da un articolo 18 più flessibile. La spirale recessiva continua pertanto ad aggravarsi, svenando ulteriormente le casse dello Stato per gli interventi a favore dei disoccupati (cassa integrazione, indennità di mobilità). Le cifre delle integrazioni salariali sembrano vanificare gli sforzi dei tagli lineari eseguiti in nome dell'austerità. Inoltre, i licenziamenti continuano a ingolfare le aule di tribunale. Il rischio è che la già drammatica situazione della giustizia civile si deteriori ancora di più con un regime di “licenziamenti facili”. Infine, i dati sugli investimenti stranieri in Italia non sono ancora disponibili. Tuttavia, il fatto che le remore degli operatori stranieri (e italiani) dipendano più che altro dai tempi della giustizia, dalla criminalità e dal peso della burocrazia ci fanno immaginare l’impatto minimo che la riforma dell’articolo 18 avrà anche nell’attirare gli investimenti.
Non è un caso che nel suo discorso di insediamento il Presidente del Consiglio Letta abbia rotto il tabù dell’intoccabilità della riforma Fornero, programmando una “riforma della riforma”. Letta, però, sembra volersi mettere in linea di continuità con il governo Monti, nel segno di una sempre maggiore flessibilità e svalutazione del lavoro. Un esempio inquietante della strada che potrebbe seguire il nostro Paese proviene dalla Grecia, dove le lobby delle multinazionali fanno pressione per abbassare il salario minimo per il lavoro part time a 250-300 euro mensili.
Il fallimento delle politiche conservatrici in materia di mercato del lavoro riposa sulla pia illusione che una riforma del diritto del lavoro a vantaggio dei datori sia sufficiente a rimettere in moto l’economia. Ma così non è. I campi d’intervento sono altri: redistribuire il reddito rinnovando la progressività del sistema fiscale, ridurre i tempi della giustizia civile, combattere la criminalità organizzata, promuovere investimenti pubblici produttivi per la miriade di piccole opere di cui l’Italia ha bisogno (in primis infrastrutture). La strada degli investimenti pubblici, tuttavia, è difficilmente praticabile, dato che la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, imponendo in linea di principio l’equivalenza tra entrate e spesa, ammette l’indebitamento solo in casi eccezionali e a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere. In assenza della maggioranza richiesta, nuova spesa potrebbe essere possibile solo aumentando la pressione fiscale; una strada, appunto, impraticabile. La strada opposta (abbassare spesa e tasse), pur essendo “costituzionalmente conforme”, non sembra però molto sicura, dato che, secondo autorevoli economisti, comporterebbe gravi effetti recessivi.
Nel dibattito pubblico, salvo casi sporadici, questi temi sono completamente assenti, a parte la generica constatazione dell’insufficienza della riforma Fornero. La così detta società civile sembra troppo assorta nel seguire le avventure sessual-giudiziarie di un vecchio uomo politico. Intanto l’Italia continua la sua corsa verso la disoccupazione, la recessione e la deflazione. La notte è ancora lunga.
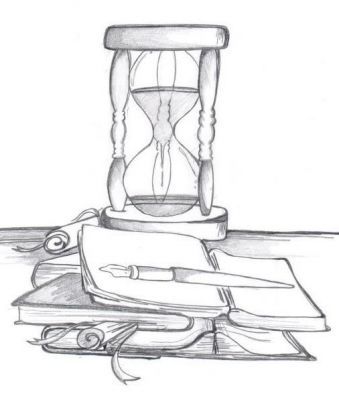
In collaborazione con La Clessidra
Commenta