Il voto e il volto della Germania
Il lato oscuro del mercantilismo tedesco
Se i risultati delle elezioni in Germania sono chiari, la loro interpretazione lo è un po’ meno. La lettura prevalente si è concentrata sullo straordinario risultato della signora Merkel, il cui partito ha sfiorato la maggioranza assoluta dei seggi. Alcuni osservatori hanno utilizzato questo dato per tessere le lodi del così detto modello tedesco, invitando i policy maker di tutta Europa a imitarlo pedissequamente. Il trionfo della Cancelliera di ferro è indiscutibile, ma il dato andrebbe collocato all’interno di una descrizione complessiva della situazione politica e sociale tedesca.
Alla vittoria elettorale della Merkel, infatti, fanno da contraltare, da un lato, la scomparsa parlamentare dei suoi alleati liberali FDP (insieme al mancato ingresso in Parlamento degli anti-euro AfD), e, dall’altro lato, il fatto che socialdemocratici, verdi e socialisti della Linke abbiano complessivamente ottenuto la maggioranza assoluta in Parlamento. Tutti sanno che questo non porterà ad alcuna maggioranza di governo di “centro-sinistra”. Il dato, tuttavia, è interessante perché suggerisce un generico spostamento dell’elettorato verso “sinistra”. Ma il dato forse più significativo, e sicuramente il meno considerato, è costituito dal preoccupante livello di astensione, che continua ad aggirarsi intorno al 30%. Probabile espressione di sfiducia e malessere, l’astensione, come nel 2009, penalizza soprattutto i socialdemocratici nelle regioni più povere (tendenzialmente ex DDR).
 Esclusione dell’“estrema destra” economica dal Parlamento (FDP, AfD), fuga massiccia nel moderatismo democristiano CDU-CSU, maggioranza assoluta di “centro-sinistra” (SPD, Verdi, Linke), astensione record: questo è il quadro in cui deve essere collocato l’innegabile trionfo della signora Merkel. L’immagine di una Germania prospera, unita festosa intorno al suo leader, ne esce scalfita. Il fatto è che le contraddizioni che caratterizzano i risultati delle elezioni politiche in Germania riflettono in larga misura i contrasti che attraversano la società tedesca e il suo modello di sviluppo economico.
Esclusione dell’“estrema destra” economica dal Parlamento (FDP, AfD), fuga massiccia nel moderatismo democristiano CDU-CSU, maggioranza assoluta di “centro-sinistra” (SPD, Verdi, Linke), astensione record: questo è il quadro in cui deve essere collocato l’innegabile trionfo della signora Merkel. L’immagine di una Germania prospera, unita festosa intorno al suo leader, ne esce scalfita. Il fatto è che le contraddizioni che caratterizzano i risultati delle elezioni politiche in Germania riflettono in larga misura i contrasti che attraversano la società tedesca e il suo modello di sviluppo economico.
Per comprendere meglio l’attuale situazione occorre prendere le mosse dagli ultimi anni del secolo scorso, quando la Repubblica federale era definita il “grande malato d’Europa”, afflitto da un’elevata disoccupazione, da una sostanziale stagnazione e dalla crescita del debito pubblico. In quel torno di anni il governo socialdemocratico di Schröder mise in atto una serie di riforme strutturali. Per affrontare la sfida della competizione globale, i socialdemocratici abbracciarono gli interessi del grande capitale nazionale. Da un lato, fu avviata una decisa politica di riduzione della tassazione sui profitti e di moderazione dei salari, aumentando la pressione sui disoccupati, precarizzando le condizioni lavorative e riducendo pensioni e spese sociali; dall’altro lato, il governo condusse un’oculata politica industriale, volta ad adattare l’enorme apparato produttivo tedesco alle esigenze della domanda europea e internazionale di merci.
Il modello di sviluppo tedesco contemporaneo, dunque, può essere definito neo-mercantilista. Si tratta di un modello di crescita frenata, trainato cioè dalle esportazioni (favorite anche dal fatto che l’euro offre un vantaggio competitivo maggiore del troppo forte marco) ma caratterizzato anche da una depressione dei consumi nazionali (che si traduce anche in una riduzione delle importazioni).
Il mercantilismo tedesco, infatti, contiene una contraddizione insanabile tra l’esplosione dell’export (+30% tra 1997 e 2011) e il crollo della domanda interna (-15% nello stesso periodo). Questa contraddizione ha alle spalle una competitività commerciale basata più sulla compressione dei salari reali dei lavoratori che sull’aumento della produttività. Infatti, negli ultimi anni la produttività totale dei fattori in Germania ha conosciuto solo un modesto aumento e il progresso tecnico in senso stretto è in linea con la media europea. Per contro, dal 2000, il salario reale medio è sceso del 4,5%, 7,3 milioni di lavoratori sono oggi occupati in mini-job senza diritti da 400 euro al mese e 1 lavoratore tedesco su 4 è considerato “scarsamente retribuito”. Il basso costo del lavoro per unità di prodotto su cui si basa la competitività tedesca, dunque, sembra dipendere essenzialmente dal contenimento delle dinamiche salariali.
La deflazione salariale, ottenuta precarizzando le condizioni di lavoro, scardinando la contrattazione collettiva e abbandonando, di fatto, il sistema tradizionale della co-determinazione, ha comportato un massiccio spostamento di reddito dal basso verso l’alto, dai  salari ai profitti, contribuendo ad acuire stridenti diseguaglianze sociali. Infatti, metà della popolazione detiene appena l’1% della ricchezza complessiva (dieci anni fa era il 4%), mentre il 10% in cima alla piramide sociale ne possiede il 53% (nel 1998 era il 45%). L’efficacia redistributiva dell’intervento statale di fronte a queste abissali diseguaglianze, per di più, risulta sempre più compromessa dal taglio delle tasse ai profitti e ai redditi più alti e all’abbandono del principio di progressività tributaria. Pertanto, le cause della caduta dei consumi e investimenti interni in Germania sembrano chiare, e precisamente rappresentano il necessario contraltare del modello di sviluppo mercantilista perseguito dal grande capitalismo tedesco.
salari ai profitti, contribuendo ad acuire stridenti diseguaglianze sociali. Infatti, metà della popolazione detiene appena l’1% della ricchezza complessiva (dieci anni fa era il 4%), mentre il 10% in cima alla piramide sociale ne possiede il 53% (nel 1998 era il 45%). L’efficacia redistributiva dell’intervento statale di fronte a queste abissali diseguaglianze, per di più, risulta sempre più compromessa dal taglio delle tasse ai profitti e ai redditi più alti e all’abbandono del principio di progressività tributaria. Pertanto, le cause della caduta dei consumi e investimenti interni in Germania sembrano chiare, e precisamente rappresentano il necessario contraltare del modello di sviluppo mercantilista perseguito dal grande capitalismo tedesco.
La crisi economica globale del 2007-2008 e le successive politiche di austerità nei Paesi mediterranei, contraendo i mercati di sbocco per le esportazioni, hanno colpito anche la Germania, azzerando la già bassa crescita del PIL e inaugurando un periodo di stagnazione. Le contraddizioni sociali così delineate trovano, insomma, uno specchio fedele nel risultato polivalente delle recenti elezioni (2009 e 2013). Infatti i socialdemocratici, autori delle riforme antipopolari degli anni Duemila, hanno subito una drammatica emorragia di voti a favore dell’astensione. L’elettorato di destra, al contrario, ha votato compatto per i democristiani, che con la cancelliera Merkel si sono presentati più moderati non solo degli ultras liberisti del FDP, ma anche degli stessi socialdemocratici post-Schröder.
Il “modello tedesco” non sembra perciò così desiderabile come spesso ci viene fatto credere. Si potrebbe comunque sostenere che stagnazione e “cattiva” occupazione siano migliori di recessione tecnica e disoccupazione; per cui, volenti o no, la germanizzazione dell’Europa sarebbe l’unica strada per uscire dalla crisi. Il fatto è che, purtroppo, l’abbattimento dei salari per lanciare le esportazioni è una politica che non può essere portata avanti contemporaneamente da tutti i Paesi europei, per un semplice vizio logico. Una gigantesca, unica manifattura europea orientata principalmente all’export extracomunitario, con la sua spropositata capacità produttiva, non troverebbe mai un mercato d’importazione tanto vasto da assorbire il suo enorme potenziale industriale. Forse sarebbe il caso di pensare alla domanda interna europea, al miglioramento delle condizioni dei lavoratori, a ridurre le diseguaglianze sociali, invece di peggiorare tutti questi indicatori a colpi di austerità.
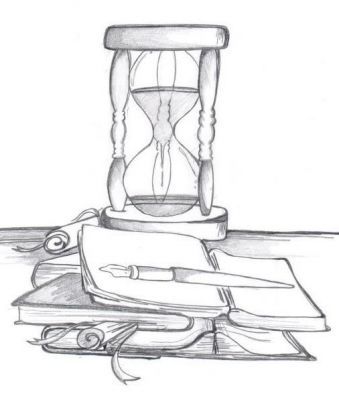
In collaborazione con La Clessidra
Commenta