Fare i conti con se stesse
Su Una donna di Annie Ernaux e il dolore della perdita di una madre
Quando si conosce troppo a fondo, come solo con i genitori può capitare, il dolore della compassione è legato al risentimento di aver lasciato dietro di sé le tracce di qualcosa di irrisolto. Il non risolto è inevitabile. Lo sfuggiamo per tutta la vita fingendo che, prima o poi, ci assumeremo la responsabilità di far chiarezza sulle cose sospese, ma non lo facciamo mai: ammettere agli altri quello che non si è mai avuto il coraggio di dire è imperdonabile, una vergogna che non possiamo scrollarci di dosso.
Questa è certo anche una vigliaccheria, una giustificazione bella e buona a cui ci aggrappiamo con le unghie, perché lasciare intendere che si sa più del dovuto è soprattutto tradire le proprie convinzioni; una frustrazione che va evitata, se non si vuol soffrire ancor peggio. Tiriamo ad andare avanti così, in sordina, e poco importa se alla fine ci ritroveremo a fare i conti con quell’ammasso di fraintendimenti voluti: noi guardiamo tutto in tralice e nel rigurgito di un orrore di fondo, nella compassione, aneliamo. Si sopravvive alla conoscenza dei genitori fingendo di saperli solo in parte, sempre con una certa mitezza, un occhio chiuso e l’altro aperto, almeno fino a quando la situazione ce lo permette.
 Una donna di Annie Ernaux, edito nella nuova ristampa da L’Orma con la traduzione di Lorenzo Flabbi – premiato per la miglior traduzione dalla Classifica di qualità della Lettura del Corriere della Sera e finalista del Premio Von Rezzori 2019 –, si apre proprio quando la finzione non può più essere soffocata: è lunedì 7 aprile, la madre della scrittrice muore all’ospedale di Pontoise.
Una donna di Annie Ernaux, edito nella nuova ristampa da L’Orma con la traduzione di Lorenzo Flabbi – premiato per la miglior traduzione dalla Classifica di qualità della Lettura del Corriere della Sera e finalista del Premio Von Rezzori 2019 –, si apre proprio quando la finzione non può più essere soffocata: è lunedì 7 aprile, la madre della scrittrice muore all’ospedale di Pontoise.
Quello che accade subito dopo è il fastidio di riconoscere che non c’è più rimedio. Si forma un gran disgusto, una voragine nauseabonda che porta ad analizzare quello che capita a tiro con fredda lucidità: non si è ancora pronti ad ammettere niente.
Il mio ex marito mi ha accompagnata all’impresa di pompe funebri. Al di là della vetrina di fiori finti, qualche poltrona e un tavolo basso con riviste. Siamo stati condotti da un impiegato di ufficio, ci ha domandato la data del decesso, il luogo dell’inumazione, messa sì e no. Prendeva nota di tutto su un grande registro, ogni tanto premeva i tasti di una calcolatrice. Ci ha portati in una stanza buia, senza finestre. Ha acceso la luce. Sistemate in verticale contro le pareti c’erano una decina di bare. L’impiegato ha precisato: “Tenga presente che tutte le tariffe sono convenzionate.” Tre bare erano aperte per decidere anche il colore del rivestimento interno. Ho scelto la quercia perché era il suo albero preferito e perché di qualsiasi mobile nuovo voleva subito sapere se fosse di quel tipo di legno.
I primi paragrafi del memoir sono fatti di frasi corte che seguono la marcia di uno stile cronachistico. La lettura procede a passo cadenzato e avanza attraverso i gesti meccanici, i momenti in cui l’autrice ci racconta quello che sta vivendo: non riesce più a far niente, versa lacrime ovunque e pensa a tutto quello che dopo, per sua madre, non ci sarà più. Se il presente è una catena che gira a scatti, lentamente il passato inizia a sciogliersi. È il momento di raccontare, di costringersi allo sconforto, scendere sotto il livello della repulsione e scrivere tutto. Come lei stessa dice «si tratta di cercare una verità su mia madre che può essere raggiunta solo attraverso le parole». Di sua madre non si conosce mai il nome, ma la si sente sempre parlare attraverso frasi messe tra virgolette che suonano come residui di pensieri complessi, gli ultimi lasciti di un’esistenza.
Se per esempio facevo presente che una compagna aveva una lavagnetta infrangibile, subito mi chiedeva se la volevo anch’io: “Che non si dica che sei meno delle altre”. Il suo desiderio più profondo era darmi tutto ciò che non aveva avuto lei. Ma questo le richiedeva un tale impegno nel lavoro, tante di quelle preoccupazioni economiche e un’apprensione nei confronti dell’infelicità infantile talmente nuova rispetto ai sistemi educativi di una volta, che non poteva far a meno di commentare: “Quanto ci costi!” o “Con tutto quello che hai, ancora non sei contenta!”.
I ricordi ripercorrono la vita di una donna nata in povertà, sempre immersa nella difficoltà di crearsi un futuro degno di dirsi tale. Sono gli anni dopo la guerra, anni di stenti che proseguono per una vita fatta di sacrifici: il lavoro, i bisogni negati, i soldi che mancano sempre, la morte di una figlia. È una donna che soffre, ma essendo il dolore cosa comune non corrode, piuttosto plasma i suoi gesti bruschi, il tono grave, la fermezza nei suoi modi di fare: soffrire non è un problema, se non ci si fa troppo caso. Non si può certo dire lo stesso della figlia, che per riflesso scandaglia le impressioni lasciate indietro da una madre ruvida che la cresce insegnandole l’importanza dell’educazione, dell’arte, pur non sapendo neanche lei di preciso a cosa si riferisca.
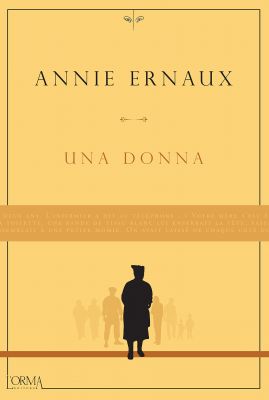 Il libro non è diviso in capitoli e nel leggerlo non ci si può mai veramente fermare. Va buttato giù tutto d’un colpo, come una medicina amara. La prosa asciutta che inghiottiamo ci lascia sempre l’impressione di stare lì, a sbirciare dietro una tenda, a guardare tra le fessure delle dita quelle emozioni che diventano intrattabili proprio perché semplici, fatte di orizzonti netti, di immagini affettive impossibili da sostenere anche ad un livello minimo di introspezione.
Il libro non è diviso in capitoli e nel leggerlo non ci si può mai veramente fermare. Va buttato giù tutto d’un colpo, come una medicina amara. La prosa asciutta che inghiottiamo ci lascia sempre l’impressione di stare lì, a sbirciare dietro una tenda, a guardare tra le fessure delle dita quelle emozioni che diventano intrattabili proprio perché semplici, fatte di orizzonti netti, di immagini affettive impossibili da sostenere anche ad un livello minimo di introspezione.
Forse è anche per questo che appare un libro profondamente triste. Non sono gli ultimi anni della vita della madre o il crollo dell’Alzheimer a farci del male, ma la descrizione dei gesti, l’affanno di una donna la cui vita è sempre stata tentare, pur non essendo adeguata; lo strisciare in avanti, sempre, e il vedere tutto questo da parte della figlia: non dirlo mai e ammetterlo scrivendo.
L’ultima volta che Annie Ernaux vede sua madre le porta un mazzo di forsizia. Lei lo guarda, cerca di allungarsi per toccarlo. Sono i suoi ultimi gesti
L’ultima volta che Annie Ernaux vede sua madre le porta un mazzo di forsizia. Lei lo guarda, cerca di allungarsi per toccarlo. Sono i suoi ultimi gesti. Il libro finisce con disincanto e l’autrice confessa di aver raccontato questa storia perché presa dalla responsabilità di fare chiarezza, per sentirsi «meno fasulla nel mondo dominante delle parole e delle idee in cui, secondo i suoi desideri, sono entrata». Smettere di mentire vuol dire limitarsi a proseguire le messinscena in atto, ripiegarsi su se stessi e, prima di andare avanti, ammettere di riconoscere quanto resta. Fare chiarezza con atti semplici, come sistemare una piccola mansarda e nell’infelicità di una scissione eterna rispolverare tutto, fare ordine, dare luce ad ogni parola non detta, rimettere i pezzi al loro posto senza lamentarsi; e quando si è finito sedersi, guardare quel museo che abbiamo messo in piedi. Chiudere la stanza a chiave, non tornare più. Mi domando come si potrebbe fare di meglio.

Commenta