Brucia Sarajevo
La lotta dei lavoratori bosniaci contro la privatizzazione predatoria
In un turbine confuso di agenzie e reportage fotografici, la Bosnia è tornata a occupare le cronache internazionali, abbandonando le vesti di Stato-fantasma a cui la storia sembrava averla costretta senza possibilità di riscatto. Manifestazioni di massa, blocchi stradali, scontri violenti, i palazzi del potere in fiamme: di fronte a tali agitazioni, non è mancato chi ha evocato lo spettro della pulizia etnica. Niente di tutto questo; le proteste, infatti, sono dichiaratamente animate dalle rivendicazioni economiche e sociali dei lavoratori bosniaci, vittime di un processo di privatizzazione dagli indiscutibili connotati predatori, portato avanti dalla cricca politico-imprenditoriale che tiene in scacco il Paese e che in passato non ha esitato ad agitare la retorica delle differenze etniche e religiose per dividere (e indebolire) qualsiasi moto popolare di opposizione e dissenso.
 La causa scatenante della protesta si è materializzata a Tuzla, dove l’ennesima privatizzazione fallimentare ha lasciato sul lastrico migliaia di lavoratori e arricchito a dismisura pochi capitali privati. Relativamente in poco tempo le sigle sindacali più combattive hanno organizzato una protesta di dimensioni nazionali, mettendo in contatto una miriade di vertenze e storie locali sparse in tutto il Paese. Le privatizzazioni a Tuzla hanno fatto deflagrare le stridenti contraddizioni sociali che hanno accompagnato la storia del modello di sviluppo economico bosniaco, adottato dal salotto buono della nascente borghesia autoctona sotto gli auspici delle istituzioni internazionali. Dopo lo smembramento della Yugoslavia socialista e i torbidi della guerra civile, la Bosnia del 1995, come il resto dei Balcani, non era che una tabula rasa in cui la priorità assoluta, per le élite economiche, era di aprire un nuovo, vasto spazio a basso costo della manodopera alla valorizzazione del capitale. Le riforme strutturali neoliberiste necessarie allo scopo furono realizzate speditamente. Il sostanziale azzeramento delle tutele legali per i lavoratori, lo scardinamento della contrattazione collettiva e l’indebolimento dei sindacati non incontrarono ostacoli particolari. Anche lo smantellamento dei servizi sociali e l’introduzione di una flat tax del 10% sui redditi, particolarmente favorevole ai percettori di alti profitti, furono velocemente effettuati, facendola finita con il concetto “totalitario” di redistribuzione del reddito e con quegli orrori del passato regime comunista rappresentati dall’assistenza sanitaria universale, dall’istruzione gratuita, dalla garanzia abitativa e dalla piena occupazione. La rivoluzione conservatrice degli anni Novanta delineava un sistema in cui gli investimenti, attirati dal basso costo del lavoro, sarebbero stati diretti alle esportazioni, dato che il misero potere d’acquisto del popolo bosniaco non avrebbe offerto sufficienti garanzie di valorizzazione del capitale.
La causa scatenante della protesta si è materializzata a Tuzla, dove l’ennesima privatizzazione fallimentare ha lasciato sul lastrico migliaia di lavoratori e arricchito a dismisura pochi capitali privati. Relativamente in poco tempo le sigle sindacali più combattive hanno organizzato una protesta di dimensioni nazionali, mettendo in contatto una miriade di vertenze e storie locali sparse in tutto il Paese. Le privatizzazioni a Tuzla hanno fatto deflagrare le stridenti contraddizioni sociali che hanno accompagnato la storia del modello di sviluppo economico bosniaco, adottato dal salotto buono della nascente borghesia autoctona sotto gli auspici delle istituzioni internazionali. Dopo lo smembramento della Yugoslavia socialista e i torbidi della guerra civile, la Bosnia del 1995, come il resto dei Balcani, non era che una tabula rasa in cui la priorità assoluta, per le élite economiche, era di aprire un nuovo, vasto spazio a basso costo della manodopera alla valorizzazione del capitale. Le riforme strutturali neoliberiste necessarie allo scopo furono realizzate speditamente. Il sostanziale azzeramento delle tutele legali per i lavoratori, lo scardinamento della contrattazione collettiva e l’indebolimento dei sindacati non incontrarono ostacoli particolari. Anche lo smantellamento dei servizi sociali e l’introduzione di una flat tax del 10% sui redditi, particolarmente favorevole ai percettori di alti profitti, furono velocemente effettuati, facendola finita con il concetto “totalitario” di redistribuzione del reddito e con quegli orrori del passato regime comunista rappresentati dall’assistenza sanitaria universale, dall’istruzione gratuita, dalla garanzia abitativa e dalla piena occupazione. La rivoluzione conservatrice degli anni Novanta delineava un sistema in cui gli investimenti, attirati dal basso costo del lavoro, sarebbero stati diretti alle esportazioni, dato che il misero potere d’acquisto del popolo bosniaco non avrebbe offerto sufficienti garanzie di valorizzazione del capitale.
Tuttavia, questo modello di sviluppo, fondato deliberatamente sulla precarietà e sull’impoverimento di ampie fasce della popolazione, nell’attesa messianica che gli immensi profitti lucrati da pochi privilegiati si sarebbero magicamente convertiti, come predica l’utopia liberale, nel benessere di tutti, non è mai riuscito a decollare. Il Paese balcanico, infatti, liquidate le grandi industrie dell’era titoista, si è specializzato nell’esportazione di materie prime non pregiate e di merci a basso valore aggiunto, cioè in settori dove la concorrenza dei colossi internazionali ha facilmente escluso la piccola Bosnia dagli sbocchi di mercato che contano. La disoccupazione endemica di cui, di conseguenza, il Paese soffre, da un lato spinge la popolazione ad accettare qualsiasi abuso venga imposto dai proprietari di capitali per ottenere o conservare il posto di lavoro (di norma in nero); dall’altro lato, costringe una porzione cospicua di forza-lavoro a emigrare. Sono state le progressive privatizzazioni, però, la vera manna per gli investitori, che hanno letteralmente saccheggiato le proprietà acquisite sottocosto, lasciando per strada migliaia di lavoratori, anche quando si trattava di aziende operanti in settori ad alto potenziale (petrolio, tabacco). Ne sono risultate, in pochi anni, la distruzione dell’80% delle aziende privatizzate e circa mezzo milione di licenziamenti. È su queste cifre da macelleria sociale che l’élite economica e politica bosniaca ha costruito le sue immense fortune.
 Gli effetti della crisi economica hanno portato a un più alto grado di intensità le contraddizioni di questo perfetto modello di “sviluppo” neoliberista. La contrazione dei mercati europei, aggravata dalle politiche di austerity, ha abbattuto sia le esportazioni sia il flusso di rimesse degli emigrati. La crisi delle esportazioni ha comportato un insopportabile incremento della disoccupazione, che ha permesso al governo di emanare misure di ulteriore precarizzazione dei rapporti lavorativi, additando (con buona dose di ironia) nelle “eccessive” garanzie per i dipendenti la radice strutturale della mancanza di lavoro. La riduzione delle rimesse dall’estero, poi, ha fatto venir meno quello che per un gran numero di famiglie bosniache rappresentava un importantissimo ammortizzatore sociale informale. Meno consumi e meno reddito, però, significano meno entrate fiscali per lo Stato. E la crisi delle finanze pubbliche bosniache è stata affrontata, come da migliore tradizione, varando un ambizioso piano di nuove privatizzazioni. Ancora, aziende pubbliche perfettamente operative sono state svendute ai privati, che hanno semplicemente depredato le proprietà, lasciando sul lastrico migliaia di lavoratori con montagne di stipendi arretrati da riscuotere e con i contributi pensionistici e sanitari non pagati.
Gli effetti della crisi economica hanno portato a un più alto grado di intensità le contraddizioni di questo perfetto modello di “sviluppo” neoliberista. La contrazione dei mercati europei, aggravata dalle politiche di austerity, ha abbattuto sia le esportazioni sia il flusso di rimesse degli emigrati. La crisi delle esportazioni ha comportato un insopportabile incremento della disoccupazione, che ha permesso al governo di emanare misure di ulteriore precarizzazione dei rapporti lavorativi, additando (con buona dose di ironia) nelle “eccessive” garanzie per i dipendenti la radice strutturale della mancanza di lavoro. La riduzione delle rimesse dall’estero, poi, ha fatto venir meno quello che per un gran numero di famiglie bosniache rappresentava un importantissimo ammortizzatore sociale informale. Meno consumi e meno reddito, però, significano meno entrate fiscali per lo Stato. E la crisi delle finanze pubbliche bosniache è stata affrontata, come da migliore tradizione, varando un ambizioso piano di nuove privatizzazioni. Ancora, aziende pubbliche perfettamente operative sono state svendute ai privati, che hanno semplicemente depredato le proprietà, lasciando sul lastrico migliaia di lavoratori con montagne di stipendi arretrati da riscuotere e con i contributi pensionistici e sanitari non pagati.
Raggiunto il punto di rottura, è esplosa la rabbia sociale, e quella conflittualità sindacale frammentaria che finora si era espressa solo a livello locale e vertenziale è stata ricondotta a unità. Serbi, Croati e Bosniaci, cristiani e musulmani, uniti dai loro interessi materiali di classe, hanno abbattuto i muri delle differenze etnico-religiose, spezzando trasversalmente le rispettive comunità e rivolgendo finalmente le armi contro i dominanti. Contro chi afferma che la vera differenza, in politica, è tra la tolleranza liberale e il fondamentalismo, la lotta dei lavoratori bosniaci porta alla ribalta una distinzione che ogni oligarchia (liberale o fondamentalista che sia) ha interesse a mantenere nell’ombra: si tratta della distinzione tra chi sfrutta e chi è sfruttato. Si legge, infatti, nel Proclama del popolo di Tuzla che scopo della protesta è di portare al potere un governo “tecnico” per realizzare un programma dagli spiccati caratteri sociali: i lavoratori devono ottenere il pagamento delle mensilità arretrate e il riconoscimento dell’anzianità; le proprietà acquisite illegalmente vanno espropriate; le ultime privatizzazioni saranno annullate, e quelle precedenti riviste; infine, le fabbriche devono essere riconsegnate ai lavoratori perché, sotto il controllo del governo, sia ripresa la produzione ove possibile. Nel frattempo sorgono nei centri della rivolta dei plenum di cittadini e lavoratori come forme di autogoverno popolare e già si parla di un possibile contagio rivoluzionario in Serbia e Croazia.
La storia di questa ribellione di massa, tuttavia, non è ancora scritta. I pericoli della repressione violenta all’interno (o dall’esterno, sotto forma di “intervento umanitario”) sono in agguato e, come da manuale, l’élite bosniaca ha già iniziato a giocare la carta dello scontro inter-etnico per indebolire la rivolta dall’interno. Quel che è certo è che non siamo assolutamente di fronte a una generica “primavera bosniaca”, magari condita con una buona dose di retorica giovanilistica e libertaria. Le proteste dei lavoratori, precari, disoccupati e studenti bosniaci, al contrario, hanno una connotazione ben precisa. Sono espressione di quello che nell’accademia viene chiamato pudicamente “conflitto sociale”. E che qualcuno chiamava lotta di classe.
non è ancora scritta. I pericoli della repressione violenta all’interno (o dall’esterno, sotto forma di “intervento umanitario”) sono in agguato e, come da manuale, l’élite bosniaca ha già iniziato a giocare la carta dello scontro inter-etnico per indebolire la rivolta dall’interno. Quel che è certo è che non siamo assolutamente di fronte a una generica “primavera bosniaca”, magari condita con una buona dose di retorica giovanilistica e libertaria. Le proteste dei lavoratori, precari, disoccupati e studenti bosniaci, al contrario, hanno una connotazione ben precisa. Sono espressione di quello che nell’accademia viene chiamato pudicamente “conflitto sociale”. E che qualcuno chiamava lotta di classe.
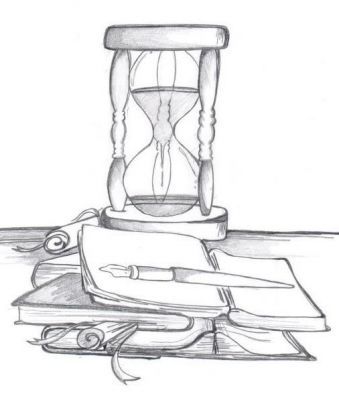
In collaborazione con La Clessidra
Galleria



Commenta