Anna Kavan, una vita immaginata
Dentro il racconto | Sulla morte e la malattia mentale nelle opere della scrittrice britannica
«Non ho alcuna informazione utile sulla Nuova Zelanda», è con inusuale reticenza che inizia il saggio di Anna Kavan del 1943, scritto per raccontare il periodo che la scrittrice ha trascorso in Nuova Zelanda. E continua dicendo: «E anche se ne avessi di certo non mi azzarderei a darvele. La trasmissione di informazioni non è il mio campo. L’unico lavoro per cui sono qualificata in quanto scrittrice indipendente e interessata alle esperienze soggettive è il racconto delle mie reazioni personali». Ironicamente «la trasmissione di informazioni», per lo più riguardanti la sua vita, ha assunto un peso significativo non solo nei suoi saggi ma anche nelle opere di narrativa. Se è nota per qualcos’altro al di là del suo romanzo Ghiaccio del 1967, lo è proprio per la sua vita: la malattia mentale, i due matrimoni disastrosi, la dipendenza dall’eroina, e tutti questi temi sono esplorati nelle sue opere. Dovreste cercare molto a fondo per trovare un articolo che non menzioni il verbale della polizia, redatto in seguito alla scoperta del suo cadavere nel dicembre del 1968 con una siringa piantata nel braccio, in cui si dichiara che nel suo appartamento di Notting Hill «c’era così tanta eroina da poter uccidere tutta la via».
Entrambe le biografie scritte su Kavan si soffermano a lungo sull’uso di stupefacenti e tendono, in modo alquanto opinabile, a usare la narrativa come fonte documentaria
Dettagli come questo stanno a significare che la narrativa e la biografia di Anna Kavan si sono mescolate assieme, cosa che l’autrice potrebbe aver incoraggiato quando ha adottato il nome di uno dei suoi personaggi come proprio, dopo aver pubblicato i primi sei romanzi col nome di Helen Ferguson. Come Zadie Smith ha scritto nel suo saggio del 2008, Two Paths for the Novel (Due strade per un romanzo) «per l’avanguardia inglese, le autobiografie estreme sono diventate un segno di autenticità letteraria, l’uso di sostanze stupefacenti di Alexander Trocchi e Anna Kavan è importante quanto la loro prosa agli occhi dei lettori». Questo è sicuramente vero per i biografi di Kavan. L’autrice ha vissuto una vita peripatetica e a volte caotica, di cui per lo più non abbiamo testimonianze, avendo lei distrutto molte delle sue lettere e tutti i suoi diari tranne uno (1926-1927). Come risultato, entrambe le biografie scritte su Kavan si soffermano a lungo sull’uso di stupefacenti e tendono, in modo alquanto opinabile, a usare la narrativa come fonte documentaria, arrivando al punto di far coincidere le battute di un personaggio con le parole pronunciate dall’autrice. Come ha scritto Victoria Walker nell’introduzione di una recente raccolta di racconti e articoli di Kavan, «le esperienze fittizie dei suoi personaggi sono state usate per romanzare la sua biografia».
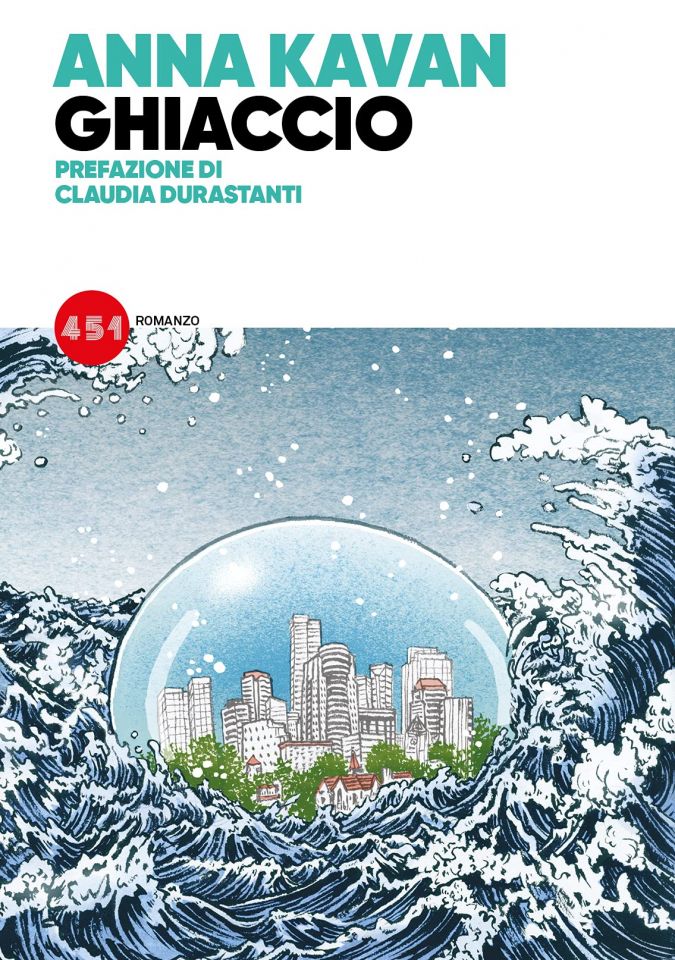
«Anna scriveva in uno specchio» riporta l’amica di Kavan Rhys Davies in un articolo commemorativo, ma in un certo senso lo fanno tutti. C’è un aspetto di genere nella discussione del lavoro di Kavan. Agli scrittori è permesso immaginare mentre alle scrittrici solo di confessarsi; Flaubert può dire «Madame Bovary, c’est moi» senza essere accusato di narcisismo. In ogni caso, la domanda non è tanto se un autore rispecchia la propria vita nel suo lavoro quanto se ciò che vi riflette è interessante per gli altri. Per capirlo, non c’è bisogno di andare più in là del primo libro che Kavan ha pubblicato sotto pseudonimo, Impressioni di follia (1940). È stata la sua prima raccolta di racconti e anche il suo primo capolavoro, nonostante lo scoppio della Seconda guerra mondiale lo abbia portato a essere presto dimenticato malgrado le eccellenti recensioni.
Il libro consiste di due cicli principali e di altre piccole storie di contorno. Le otto parti del racconto Impressioni di follia si ispirano all’esperienza dell’autrice in un manicomio svizzero, ma non si tratta di un testo autobiografico. Una delle parti migliori, la settima, descrive la fuga da un manicomio, in barca a remi, di un avvocato francese. Quando inizia ad attraversare il lago di Ginevra è convinto di stare «abbastanza bene – non è che ci sia mai stato qualcosa che davvero non andava in me» e per poco contempla il pensiero che le ragioni di sua moglie per farlo internare non fossero proprio oneste. Ma poi si fa via via più insicuro mentre attraversa il lago, e spiacevoli pensieri iniziano ad affollarglisi in testa: «i gendarmi, le domande, le occhiate» che avrebbe dovuto affrontare nel momento in cui avrebbe messo piede a riva. Alla fine, a qualche metro dalla libertà, «abbattuto e logorato», un uomo «molto più vecchio» di quello che era partito, gira la barca e torna al manicomio. Nel tracciare la presa di coscienza di un uomo sul suo stato mentale, e nel descrivere un viaggio che è al contempo fisico e psicologico, questo racconto è da considerarsi il cugino de Il Nuotatore di John Cheever.
Nella raccolta si trova un impressionante minimalismo, l’abilità di creare un’atmosfera destabilizzante senza destabilizzare il testo
L’elemento più straordinario di Impressioni di follia è il modo in cui riesce a trasmettere il trauma psicologico attraverso una prosa controllatissima. Anaïs Nin, una grandissima ammiratrice di Kavan che tentò in numerose occasioni di incontrarla (l’ammirazione non era reciproca e l’incontro non ebbe mai luogo), considerava Impressioni di follia «un esempio di lucidità classica mentre si entra in mondi irrazionali». Nella raccolta si trova un impressionante minimalismo, l’abilità di creare un’atmosfera destabilizzante senza destabilizzare il testo. In una recensione di un libro del 1944 Kavan scrisse che «il racconto è come una piccola stanza in cui si concentra una luce brillante» e in Impressioni di follia quella luce brucia di una chiarezza che non lascia spazio alla pietà.
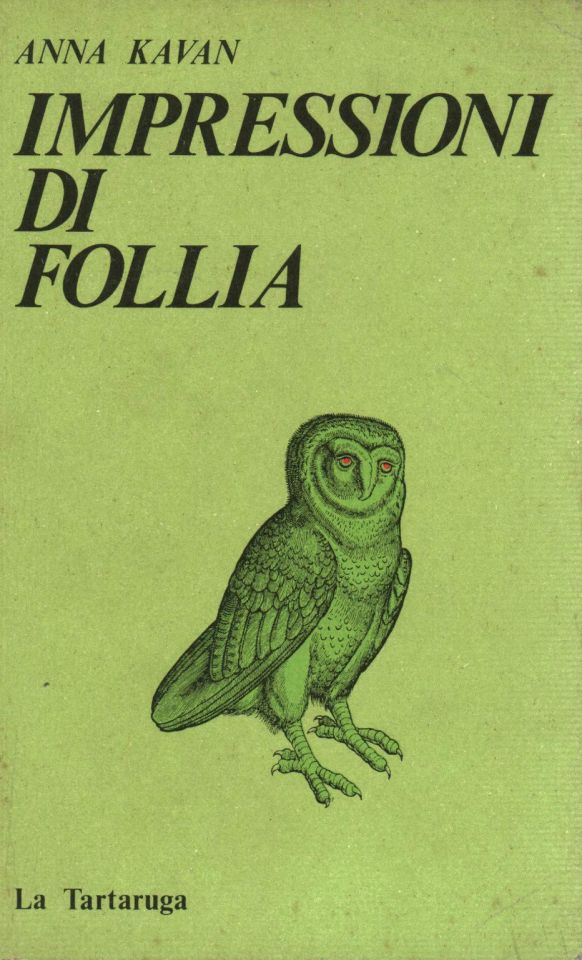
L’altro ciclo di storie della raccolta mostra quanto Kavan debba a Kafka (Brian Aldiss l’aveva soprannominata «la sorella di Kafka», anche se forse figlia sarebbe più corretto). Li possiamo chiamare «i racconti dei consulenti», una sequenza che continua nella sua raccolta successiva I am Lazarus (Io sono Lazzaro, 1945) e nell’atmosfera dei racconti che ha scritto nei vent’anni a seguire. Qui, una donna chiede il parere di diversi «consulenti» riguardo le accuse a suo carico e il giudizio che l’aspetta. Come nel romanzo di Kafka Il processo (uno dei racconti di Kavan è intitolato The Summons [La citazione]) le accuse contro la narratrice non vengono mai specificate, i meccanismi processuali sono bloccati, e non ci è dato sapere quando ci sarà la sentenza.
Milan Kundera ne L’arte del romanzo descrive il personaggio tipo di Kafka come un funzionario: «Nel mondo burocratico non c’è iniziativa, non c’è inventiva né libertà d’azione» e difatti anche i personaggi nei racconti dei consulenti sono carenti di queste qualità. Ma lei va oltre rispetto a Kafka: il suo personaggio K ha un lavoro che interferisce con la sua persecuzione mentre le protagoniste di Kavan sono molto più isolate, fino a essere completamente rimosse dal mondo. «Il sole splendeva e io mi meravigliai di rimanere sempre dentro casa, troppo afflitta dai miei crucci per guardare fuori dalla finestra, la stagione sembrava essere passata dall’inverno alla primavera».
Le protagoniste di Kavan sono molto più isolate, fino a essere completamente rimosse dal mondo
I racconti dei consulenti sono intrisi di un’incertezza nauseabonda: le stagioni finiscono e iniziano senza che nessuno se ne accorga, ogni giorno il postino potrebbe portare la lettera che cambierà per sempre il destino dei personaggi, non si sa se questi racconti descrivano un solo interminabile caso o tanti pressoché identici. Anche quando i racconti sono senza dubbio legati, come nel caso di Airing a Grievance (Dar voce a una vertenza) e Just Another Failure (Solo un altro fallimento), in cui compare lo stesso consulente di nome D, Kavan ne logora il legame: «Penso di aver finalmente deciso che D mi ricorda un qualche ritratto visto in una mostra tempo fa» commenta la narratrice nel primo racconto mentre, nel secondo, nota che il viso di D «ricorda vagamente un altro viso che ho visto molto tempo fa, non ricordo bene dove, forse in un ritratto o in una fotografia». Questa scivolata ci suggerisce che la mente della narratrice le stia facendo qualche scherzo e rende la sua vulnerabilità di fronte alla corte ancora più vivida. Molti dei racconti del ciclo dei consulenti suggeriscono una complessità del caso processuale simile a quella che troviamo in Jarndyce contro Jarndyce, in Casa desolata di Dickens. Nel racconto Our City (La nostra città) la narratrice si riferisce «all’enorme e intricato labirinto che un caso, che viene portato avanti da tanto tempo quanto il mio, finisce invevitabilmente per diventare». La conclusione da trarre da questo – e dall’opera di Kafka – è che il processo contro qualcuno, e l’esistenza di quel qualcuno, sono identici.
Oltre al ciclo di storie dei consulenti, Kavan scrive di situazioni in cui i suoi personaggi, che il più delle volte sono donne, sono messi in situazioni cariche di minaccia e incertezza, ma in cui hanno una capacità d’azione più ampia. In Benjo, la narratrice sta lavorando a casa sua, nelle campagne della Nuova Zelanda. Benjo, un uomo imperscrutabile che vive in un caravan dissestato, assiste al suo travaglio «sorridendo per tutto il tempo, con quella tipica espressione compiaciuta che potrebbe avere un padrone di casa quando l’affittuario gli migliora la proprietà». Benjo è un capolavoro di tensione: realismo nei dettagli, ma con il ritmo di una storia di fantasmi per il modo in cui calibra ansia e mistero. A Bright Green Field (Un campo verde brillante), il racconto che dà il nome alla raccolta del 1958, è invece una vera e propria storia di fantasmi, anche se un campo verde dev’essere il fantasma più improbabile che sia mai apparso in letteratura:
«Durante i miei viaggi mi sono sempre dovuta confrontare con un particolare campo. Sembra che io semplicemente non possa sottrarmici. Qualsiasi viaggio, non importa da dove parto, finisce per forza con la vista verso sera di questo prato, abbastanza piccolo, in pendenza e vicino ad alberi alti e scuri».
Nell’evocazione di questa alterità alpina o scandinava, il campo verde sembra simboleggiare un aspetto ineluttabile della psiche della narratrice: «Se non oggi o domani, allora il giorno dopo, o quello dopo ancora, alla fine di un viaggio una sera, vedrò il campo verde brillante che mi aspetta ancora. Come sempre». Durante la guerra Kavan lavorò al Mill Hill Emergency Hospital, nella periferia nord di Londra, dove furono evacuati la maggior parte dei pazienti del ben più centrale Maudsley Hospital durante i bombardamenti. Intervistò soldati con problemi psicologici e l’esperienza, combinata ai suoi internamenti, le diede ulteriori strumenti per scrivere di stati mentali fragili. I am Lazarus tratta di un giovane inglese in un ospedale francese. Ha fatto una terapia oppiacea e sembra molto migliorato, ma rimane un’inquietudine di fondo: «In qualsiasi momento poteva saltargli in mente un affare che le medicine non riuscivano a smorzare. Aspettava nervosamente in territorio nemico». Nel racconto The Blackout (Il blackout), un potente resoconto di quella che sembra essere sindrome da stress post traumatico, una frase su tutte le altre trasmette lo stato mentale del giovane soldato: «La stanza era piccola e non c’era proprio niente di allarmante in questo». Mentre la maggior parte di noi ha un’esperienza del mondo come un posto sicuro che solo ogni tanto può diventare pericoloso, la sua relazione col mondo è stata orribilmente rovesciata. Per lui non è la presenza di una minaccia ma la sua assenza a essere qualcosa di straordinario.
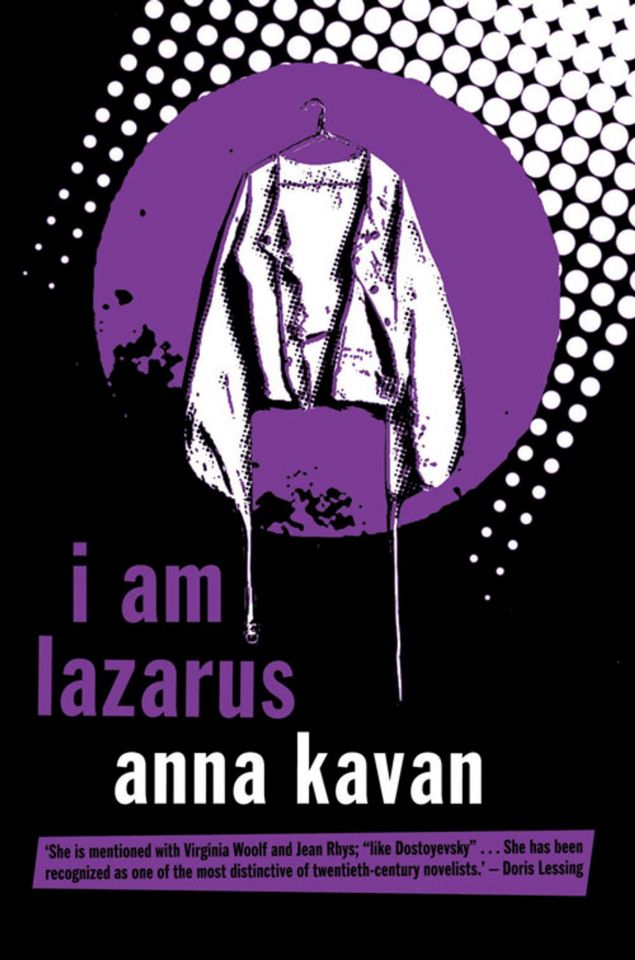
In Glorious Boys (Ragazzi gloriosi), una donna in una Londra notturna «che vibrava al suono dei caccia bombardieri» barcolla sull’orlo di un esaurimento, preda di pensieri che descrive come «il lavoro del sabotatore nei nervi». La psiche di Kavan era ugualmente fragile, qualcosa a cui ha cercato di porre rimedio iniettandosi eroina per gran parte della sua vita da adulta. Nonostante questo aspetto e la sua reputazione di scrittrice tossicodipendente, nei suoi libri non vi sono riferimenti alle droghe se non si conta la raccolta postuma Giulia e il bazooka (1970). In uno dei cicli narrativi più rilevanti di questa raccolta Kavan cerca di affrontare il lutto in seguito alla morte, nel 1964, del suo dottore Karl Bluth, che le aveva prescritto legalmente l’eroina per almeno vent’anni. Il migliore di questo ciclo è The Mercedes, un racconto dall’atmosfera onirica in cui M, il surrogato di Bluth, sta provando a tornare a casa dall’appartamento del narratore in una notte di pioggia. Fuori la coppia trova una macchina comparsa misteriosamente a bordo strada. Quando M entra, la macchina parte all’improvviso. Il narratore non riesce ad aprire la portiera o a rendersi conto di cosa succede mentre la macchina scivola via «senza incontrare ostacoli e senza emettere alcun suono proprio come l’acqua che scorre giù, verso il fondo, senza che la si possa fermare». Ha smesso di piovere e la strada scivolosa sembra «un fiume nero». Possiamo supporre che lo sia davvero e che abbia anche un nome: Stige.
La danza più commovente che si ha con la morte, nell’opera di Kavan, è un suicidio mancato
La morte è una costante nelle opere di Anna Kavan, ma le sue ultime opere la presentano con particolare insistenza. L’autrice ha tentato il suicidio diverse volte e molti dei suoi personaggi sono sul punto di togliersi la vita. In uno dei racconti dei consulenti, An Unpleasant Reminder (Un promemoria spiacevole) alla narratrice viene data una pillola per suicidarsi, «la sentenza che ho aspettato così a lungo». Quando la prende, tuttavia, salta fuori che si trattava di nient’altro che una pillola di zucchero, «giusto un promemoria di quello che mi aspetta». In un altro racconto un uomo in un matrimonio infelice considera le sue vie di fuga: «Una bottiglia di barbiturici piena per tre quarti nel bagno. La mia pistola. Il gas di scarico della macchina. Le lamette del rasoio». Ma la danza più commovente che si ha con la morte, nell’opera di Kavan, è un suicidio mancato. In One of the Hot Spots (Uno dei posti caldi) la narratrice è su una barca al largo dell’isola di Giava e si chiede come sarebbe «sprofondare giù nell’oceano in una notte buia mentre tutti dormono». Il commissario di bordo le racconta che una volta ha visto un uomo saltare giù dalla barca «a piedi uniti con ancora indosso le scarpe di pelle». Ma quando il commissario si era avvicinato alla ringhiera, aveva visto lo stesso uomo salire su dalla scaletta della barca. Tornato sul ponte, l’uomo aveva controllato l’orologio ed era tornato nella sua cabina. Si è tentati di leggere in questo suicidio mancato un riferimento al padre di Kavan, che cadde o, più probabilmente, si gettò dalla prua di una nave al largo della costa del Messico quando lei aveva dieci anni.
In Our City, la narratrice considera la sua collezione di libri «come membri di una squadra suicida che non esistano a combattere un nemico infinitamente superiore: la vita». I suoi libri offrono la stessa protezione? Presi nel loro insieme, i racconti di Kavan ci presentano una serie di personaggi che vengono sfidati e, il più delle volte, travolti dalla vita. «La vita è solo un incubo e l’universo non ha senso» scriveva al suo amico Raymond Marriott nel 1965, e le sue opere, piene di «luce brillante», non offrono alcuna falsa consolazione. Questa è una delle sue qualità più persistenti. In una straordinaria recensione, pubblicata su The Horizon nel 1964, Kavan disse:
«Scrittori della qualità di Kafka e Gogol non scappano dalla realtà. Hanno troppa integrità, sia come artisti che come esseri umani, per concedersi a fantasie escapiste. Straordinariamente sensibili e vulnerabili, non fuggono da nulla… Il valore artistico delle loro opere continua a durare perché è anche parte della realtà. È consapevole, personale, vero e non scende a compromessi. È la vita».
È la vita, e non si sottrae al confronto con la morte. Come K di Kafka sappiamo quale sarà la nostra sentenza. Anna Kavan potrebbe aver scritto in uno specchio, ma quello che ci ha visto è quello che tutti vedremo, presto o tardi.
Chris Power è un critico letterario e scrittore inglese, autore della raccolta di racconti Mothers (2018) e del romanzo A Lonely Man (2021). Dal 2007 tiene sul Guardian la rubrica monografica dal titolo A brief survey of the short story, di cui questo articolo pubblicato il 25/08/2010 fa parte ► ‘Enough heroin to kill the whole street’: does Anna Kavan's life overshadow her fiction? | Traduzione di Erica Francia

Commenta